| Oggetto | Barletta, chiesa di Santa Croce | |
|---|---|---|
| Collocazione | a stampa | |
| Immagine |   | |
| Materiali e tecniche | incisione | |
| Dimensioni | ||
| Cronologia | 1783 | |
| Autore | ||
| Soggetto | Barletta | |
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | ||
| Famiglie e persone | ||
| Note | ||
| Riproduzioni | A stampa in Saint-Non 1781-1786, III | |
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Saint-Non 1781-1786: Jean-Claude Richard de Saint-Non, Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile, 4 voll., Paris, s.n., 1781-1786. [vol. 1.1; vol. 1.2;vol. 3; vol. 4.1; vol. 4.2]. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | ||
| Data di compilazione | 03/12/2013 11:05:27 | |
| Data ultima revisione | 28/01/2017 22:38:57 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/176 |
| Oggetto | Barletta, pianta (1780) | |
|---|---|---|
| Collocazione | ||
| Immagine |   | |
| Materiali e tecniche | ||
| Dimensioni | ||
| Cronologia | 1780 | |
| Autore | ||
| Soggetto | Barletta | |
| Descrizione | La pianta raffigura la città di Barletta con esatta identificazione delle mura e dei principali edifici. | |
| Iscrizioni | ||
| Famiglie e persone | ||
| Note | ||
| Riproduzioni | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | ||
| Allegati | ||
| Link esterni | Consultabile on line. | |
| Schedatore | ||
| Data di compilazione | 14/11/2013 14:10:13 | |
| Data ultima revisione | 20/02/2017 20:53:48 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/174 |
| Oggetto | Barletta, pianta Esperti (1793) | |
|---|---|---|
| Collocazione | a stampa | |
| Immagine |   | |
| Materiali e tecniche | incisione | |
| Dimensioni | ||
| Cronologia | 1793 | |
| Autore | Gabriele Pastore | |
| Soggetto | Barletta | |
| Descrizione | 1 Castello 3 Chiesa di S. Cataldo 7 Lazzaretto 8 Chiesa del Lazzaretto 9 Porto 10 Chiesa del Carmine 11 Regia Dogana 12 Palazzo di Abate 13 Quartiere vecchio 14 Real Monte di Pietà 15 Chiesa e Monastero della Vittoria 16 Palazzo di Fraggianni 17 Chiesa e Monastero di S. Stefano 18 Largo di S. Stefano 19 Chiesa dei Teatini 20 Palazzo di Campanile 21 Mulino della Città 22 Casa dei Buonfratelli 23 Chiesa della Ss. Trinità 24 Paraticchio 25 Porta Reale 26 Largo di S. Agostino 27 Chiesa della Camerella 28 Chiesa di S. Agostino 29 Borgo 31 Largo di S. Giacomo 32 Casa di Feliù 33 Casa di Cafiero 34 Casa di Spera 35 Casa di Leoncavallo 36 Casa di Leoncavallo 38 Porta Nuova 39 Chiesa dello Spirito Santo 40 Chiesa e Monastero dell’Annunziata 41 Largo dell’Annunziata 42 Casa di del Monaco 43 Casa di Ortona 44 Casa di De Leòn 45 Casa di Del Giudice 46 Chiesa del Santo Sepolcro 47 Strada della Cordoneria 48 Statua di Eraclio 49 Fortino di S. Antonio 50 Chiesa di S. Antonio 51 Chiesa dei Greci 52 Chiesa di S. Lucia 53 Fortino 55 Strada del Cambio 56 Regia Posta 57 Chiesa di S. Chiara 58 Palazzo di Esperti 59 Palazzo di Elefante 60 Palazzo di Leone 61 Palazzo di Scioti 62 Palazzo di Pappalettere 63 Palazzo di Azzariti 65 Chiesa del Purgatorio 66 Piazzetta 67 Casa di Bassi 68 Casa di De’ Gregorio 69 Largo di De’ Gregorio 70 Casa di Bruotski 71 Casa di Procacci 72 Chiesa Madre 73 Chiesa di S. Pietro 75 Strada 77 Palazzo di Seccia 78 Casa di Fucilli 79 Palazzo di Gargano 80 Palazzo di Marulli 81 Palazzo del Real Monte 82 Porta della Croce 83 Strada del Pesce 84 Casa di De’ Fazio 86 Palazzo Arcivescovile 87 Largo del Real Monte 89 Largo della Vittoria 90 Strada della Corte 92 Casa Campanile 93 Casa di De Ruggiero 94 Abitazione di Pecorari 95 Chiesa di S. Marta 96 Teatro 97 Chiesa di S. Antonio Abate 98 Paniere del Sabato 99 Casa di Cafagna 100 Casa di Celentano 101 Fossato della Città 102 Taverna di Marulli | |
| Iscrizioni | Entro una ricca cornice al di sotto della pianta: A Sua Eccellenza / Il Sig. D Giorgio Esperti / Nobile Patrizio della Città di Barletta / Regio Segreto, e Mastro Portolano / di Puglia / Gabriele Pastore / con tutt’ossequio dedica / e rassegna".
Al di sotto del cartiglio: "Amnis, et Adriacas retro fugit Aufidus Undas / Virg. Aeneid L. XI"
Ancora più sotto, entro cartiglio: "Prima pianta dimostrativa della / Fedelissima Città di Barletta/ fatta nel 1793"
A sinistra della pianta la prima parte della legenda: "1 Castello 2 Chiesa di S. Andrea 3 Chiesa di S. Cataldo 4 Porto di mare 5 Molo antico 6 Molo nuovo 7 Lazzaretto 8 Chiesa del Lazzaretto 9 Porto 10 Chiesa del Carmine 11 Regia Dogana 12 Palazzo di Abate 13 Quartiere vecchio 14 Real Monte di Pietà 15 Chiesa e Monastero della Vittoria 16 Palazzo di Fraggianni 17 Chiesa e Monastero di S. Stefano 18 Largo di S. Stefano 19 Chiesa dei Teatini 20 Palazzo di Campanile 21 Mulino della Città 22 Casa dei Buonfratelli 23 Chiesa della Ss. Trinità 24 Paraticchio 25 Porta Reale 26 Largo di S. Agostino 27 Chiesa della Camerella 28 Chiesa di S. Agostino 29 Borgo 30 Chiesa di S. Giacomo 31 Largo di S. Giacomo 32 Casa di Feliù 33 Casa di Cafiero 34 Casa di Spera 35 Casa di Leoncavallo 36 Casa di Leoncavallo 37 Casa di del Vecchio 38 Porta Nuova 39 Chiesa dello Spirito Santo 40 Chiesa e Monastero dell’Annunziata 41 Largo dell’Annunziata 42 Casa di del Monaco 43 Casa di Ortona 44 Casa di De Leòn 45 Casa di Del Giudice 46 Chiesa del Santo Sepolcro 47 Strada della Cordoneria 48 Statua di Eraclio 49 Fortino di S. Antonio 50 Chiesa di S. Antonio 51 Chiesa dei Greci".
La seconda parte è a destra: "52 Chiesa di S. Lucia 53 Fortino 54 Porta di Trani 55 Strada del Cambio 56 Regia Posta 57 Chiesa di S. Chiara 58 Palazzo di Esperti 59 Palazzo di Elefante 60 Palazzo di Leone 61 Palazzo di Scioti 62 Palazzo di Pappalettere 63 Palazzo di Azzariti 64 Palazzo di Bonelli 65 Chiesa del Purgatorio 66 Piazzetta 67 Casa di Bassi 68 Casa di De’ Gregorio 69 Largo di De’ Gregorio 70 Casa di Bruotski 71 Casa di Procacci 72 Chiesa Madre 73 Chiesa di S. Pietro 74 Palazzo di Santacroce 75 Strada 76 Chiesa di S. Domenico 77 Palazzo di Seccia 78 Casa di Fucilli 79 Palazzo di Gargano 80 Palazzo di Marulli 81 Palazzo del Real Monte 82 Porta della Croce 83 Strada del Pesce 84 Casa di De’ Fazio 85 Chiesa di Nazareth 86 Palazzo Arcivescovile 87 Largo del Real Monte 88 Palazzo di Affaitati 89 Largo della Vittoria 90 Strada della Corte 91 Palazzo Pretoriale 92 Casa Campanile 93 Casa di De Ruggiero 94 Abitazione di Pecorari 95 Chiesa di S. Marta 96 Teatro 97 Chiesa di S. Antonio Abate 98 Paniere del Sabato 99 Casa di Cafagna 100 Casa di Celentano 101 Fossato della Città 102 Taverna di Marulli" | |
| Famiglie e persone | In alto, sui tre lati, sono gli stemmi di alcune famiglie nobili di Barletta, da sinistra: Bonelli, Pecoraro, Scioti, Abate, Pappalettere, Elefante, stemma città Barletta, Marulli, Affaitati, Baldachino Sars, Leone, Santacroce, Campanile. | |
| Note | ||
| Riproduzioni | Gelao 1988, p. 22. | |
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Gelao 1988: Clara Gelao, "Palazzi con bugnato a punta di diamante in terra di Bari", Napoli Nobilissima, s. 4, XXVII,1988, 12-28. Vitale 1979: Giuliana Vitale, "Note di socio-topografia della città di Trani dall'XI al XV secolo", Archivio storico per le province napoletane, s.3, XVIII (=97), 1979, 31-97. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 12/01/2014 14:16:25 | |
| Data ultima revisione | 28/01/2017 22:39:28 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/202 |
| Oggetto | Barletta, veduta del Seggio del Popolo e del Colosso | |
|---|---|---|
| Collocazione | ||
| Immagine |   | |
| Materiali e tecniche | ||
| Dimensioni | ||
| Cronologia | 1843 | |
| Autore | ||
| Soggetto | Barletta | |
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | ||
| Famiglie e persone | ||
| Note | ||
| Riproduzioni | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | ||
| Allegati | ||
| Link esterni | Consultabile on line. | |
| Schedatore | ||
| Data di compilazione | 18/12/2013 20:39:28 | |
| Data ultima revisione | 20/02/2017 20:54:46 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/201 |
| Oggetto | Barletta, archivio della cittÓ | |
|---|---|---|
| Tipologia | edificio pubblico: archivio | |
| Nome attuale | ||
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1491: dai capitoli concessi in quell'anno da re Ferrante risulta che il sigillo e le scritture dell'universitas si custodivano "in la ecclesia nominata lo Sepulcro" (Trinchera 1866-1874, III, p. 131). 1567: l'epigrafe con questa data attesta che all'epoca l'edificio aveva già la destinazione di archivio. 1784: l'altra epigrafe documenta la continuità di funzione. | |
| Autore | ||
| Committente | Universitas di Barletta | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | La sede dell'archivio della città sorge accanto alla chiesa del Santo Sepolcro e fu costruita a spese dell'Università. All'interno era custodito l'archivio della città di Barletta. Si accedeva dalla sagrestia della chiesa, salendo cinque gradini. | |
| Iscrizioni | Iscrizione del 1567 sull'architrave della finestra | |
| Stemmi o emblemi araldici | All'esterno è lo stemma in pietra della città di Barletta. | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 140.
Trinchera 1866-1874: Francesco Trinchera, Codice Aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del Reame e le relazioni all'estero, 3 voll., Napoli 1866-1874, III, 113-131. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, II, 25. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 27/09/2013 10:38:06 | |
| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:41:35 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/515 |
| Oggetto | Barletta, cantina della Disfida | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo | |
| Nome attuale | Palazzo Damato | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Osteria del Veleno | |
| Cronologia | 1503, 15 gennaio-13 febbraio: in una cena organizzata da Consalvo di Cordova in una cantina presso la sua residenza si generò un diverbio tra soldati francesi e italiani che si concluse con la Disfida del 13 febbraio. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | Consalvo di Cordova, Gran Capitano delle truppe spagnole di stanza in Italia (1503). Famiglia Damato. | |
| Descrizione | Il palazzo Damato che, secondo le fonti (Historia 1633) avrebbe ospitato il Gran Capitano durante le operazioni militari a Barletta, è un edificio del sec. XV, come rivela l'impianto generale, il prospetto e le parti interne. La facciata presenta al centro un portale ad arco acuto riquadrato da una cornice a piccole bugne a diamante (come nel Palazzo Santacroce) e un paramento a conci di calcare di medie dimensioni e ben connessi che, al di sopra della linea del portale, si trasformano in bugne a risparmio, secondo una tipologia presente nell'architettura della regione del primo rinascimento. Anche i locali della cantina, posti nella parte sinistra dell'edificio, presentano le strutture interne, con ampi pilastri che reggono archi acuti e volte a crociera, coevi con il prospetto. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Il palazzo, oggi detto della famiglia Damato e che sarebbe stato requisito per ospitare il Gran Capitano Consalvo di Cordova durante le operazioni militari a Barletta (1503) e nel quale sarebbe avvenuto il casus belli della disfida, si presenta in un assetto ancora originale, risalente al sec. XV, come mostrano il prospetto, gli ingressi e le strutture interne. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Barone 2011-2012: Maria Teresa Barone, Elementi morfologici dell'architettura rinascimentale in Terra di Bari. Il caso del palazzo Sylos-Calò di Bitonto, Tesi Ph.D, Università di Roma "La Sapienza" 2011-2012, 135.
Historia 1633: Historia del combattimento de' tredici italiani con altrettanti francesi, fatto in Puglia tra Andria e Quarata, Napoli 1633 (II ed. Napoli 1725).
Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta, Bari 1842, 87-91. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Antonio Milone | |
| Data di compilazione | 02/02/2014 15:28:29 | |
| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:48:37 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/670 |
| Oggetto | Barletta, castello | |
|---|---|---|
| Tipologia | castello | |
| Nome attuale | Museo Civico | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1046-1050: la costruzione del castello, posto a difesa del porto, sarebbe da attribuire a Pietro il Normanno. Di questo primitivo edificio rimangono tracce soltanto nella porzione inferiore della torre di sud-est. 1202: prima attestazione scritta dell'esistenza del castello. 1224: Federico II promuove lavori di rinnovamento. 1269: Carlo I d'Angiò decide il rinnovamento del castello. 1273: si redige la stima dei lavori da eseguire. 1276: si dà avvio ai lavori, diretti da Pierre d’Angicourt. 1277: si rinforza il castello e si costruisce la cappella. 1278: crolla il muro verso il porto e se ne progetta la ricostruzione. 1280: si avvia il completamento della torre rotonda. 1281: si realizza la cisterna. 1291: completamento dei lavori sotto Carlo II d'Angiò. 1532-37: ha inizio il grande rifacimento promosso da Carlo V, con progetto inviato da Ferrante de Alarçon, castellano di Brindisi e soprintendente di tutte le fortificazioni pugliesi, e lavori assunti dal maestro Giovanni Filippo Terracino della Cava. Si costruisce il bastione sud-est detto della Nunziata. 1555-1559: seconda grande campagna di rinnovamento, che porta al completamento del bastione della Nunziata compreso di merlatura, e alla costruzione delle cortine est, nord e ovest, degli altri tre bastioni (di Sant'Antonio, poi San Giacomo a nord-est; di San Vincenzo a nord-ovest; di Santa Marta a sud-ovest), dei sotterranei, di due cisterne nel cortile e del nuovo ingresso da sud. 1559-1570: pavimentazioni al primo piano del lato ovest e scala del cortile. 1581-1582: primo piano del lato sud. gradinata est, e proseguimento della cortina occidentale interna. 1585-1586: copertura dei bastioni di Sant'Antonio e di San Vincenzo. 1596-1597: si scava il fossato. 1622: Filippo IV fa realizzare sul terrazzo ovest il laboratorio degli artificieri. | |
| Autore | Pierre d'Angicourt (fase angioina) Don Ferrante de Alarçon (riedificazione cinquecentesca) | |
| Committente | Pietro il Normanno Federico II Carlo I d'Angiò Carlo II d'Angiò Carlo V Universitas di Barletta (eroga 14mila ducati in rate di mille ducati annui) Filippo IV | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | Il castello ha un impianto quadrato, con bastioni romboidali ai quattro vertici. Poggia su un possente basamento a scarpa circondato da un fossato. | |
| Iscrizioni | All'interno iscrizione di Carlo V Sulla porta: "IN PVLCHRAM FORMA(M) REDACTV(M) / DIDACI FELIZES CVRA A.D. 1584" (Seccia 1842, 97). | |
| Stemmi o emblemi araldici | Nella lunetta di due finestre del cortile è un'aquila (sveva?). Nell'atrio di ingresso è lo stemma di Carlo V. | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Vista (1900-1904, I, 18) ricorda che alla costruzione fu chiamata a concorrere l'universitas, con il contributo di 1000 ducati annui, che vennero erogati fino al 1542. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | Pianta in Bacile di Castiglione 1927, p. 80. | |
| Fonti/Documenti | 1202: la prima attestazione dell'esistenza del castello di Barletta (Sthamer 1926, n. 648). 1269-1291: rinnovamento angioino (Schulz 1860, IV, doc. CCXVI; Loffredo 1893, II, 305; Vista 1900-1904, I, 12-13). | |
| Bibliografia | Bacile di Castiglione 1927: Gennaro Bacile di Castiglione, Castelli Pugliesi, Roma 1927, 71-93.
Brunetti 2006: Oronzo Brunetti, L’ingegno delle mura. L’Atlante Lemos della Bibliothèque Nationale de France, Firenze 2006, 55-58.
Grisotti 1995: Marcello Grisotti, Barletta, il castello, la storia, il restauro, Barletta 1995.
Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).
Rescio 1995: Pierfrancesco Rescio, “Il contributo dell’archeologia allo studio dei castelli e dei centri storici minori: alcuni esempi”, Archivio Storico Pugliese, 1995, 179-206.
Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. Sthamer 1926: Eduard Sthamer, Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. Und Karls I von Anjou, band II, Apulien und Basilicata, Leipzig 1926. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 11-28. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 27/09/2013 10:31:07 | |
| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:51:33 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/514 |
| Oggetto | Barletta, Cattedrale | |
|---|---|---|
| Tipologia | chiesa concattedrale | |
| Nome attuale | Santa Maria | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Santa Maria de Auxilio, Sancta Maria episcopii, Sancta Maria de episcopio | |
| Cronologia | 1139: bolla di papa Innocenzo II che fissa le prerogative della chiesa di Santa Maria de Auxilio di Barulo, determinando che il vescovo di Trani, sotto la cui giurisdizione ricadeva la chiesa, non avesse se non il diritto alla Santa Visita e all’esame dei chierici ordinandi (Loffredo 1893, II, doc. VI, 265-268). 1150-53: la navata della chiesa risulta in costruzione (cfr. Iscrizioni) XII secolo, fine: costruzione della torre campanaria. 1267: riconsacrazione della cattedrale e primi acquisti di terreni. 1276: data dell'inchiesta del vescovo di Minervino sul furto delle reliquie di san Ruggero perpetrato dai barlettani ai danni della cattedrale di Canne (Loffredo, II, doc. XXIII, 310-313). 1289-1300 ca.: acquisti di suolo e di edifici per l'ingrandimento della cattedrale con la costruzione del nuovo coro. 1307: papa Clemente V concede a Giovanni Pipino da Barletta il permesso di "ampliari et dilatari opere sumptuose Maiorem ecclesiam sanctae Marie de Barolo" (cfr. Documenti). 1459, 4 febbraio: Ferrante d'Aragona viene incoronato re di Napoli in Santa Maria di Barletta. 1470: ricordando la sua incoronazione, re Ferrante concede al Capitolo di Santa Maria cento carri di sale all’anno dalle saline di Barletta, prescrivendo che un terzo dei proventi venisse impiegato per mantenere scuole di musica, lettere e teologia designate a istruire i giovani chierici (Loffredo 1893, II, 84 e doc. XXXV, 354-358). XVI secolo, prima metà: vengono avviati o lavori per il completamento della chiesa con la costruzione delle campate intermedie fra la navata romanica e il coro gotico. 1562: la chiesa vecchia e la nuova abside risultano separate e chiuse da cancellate in ferro (Vista 1900-1904, I, 62) 1559: donazioni attestano la ripresa dei lavori per unificare la chiesa (Seccia 1842, 32). 1629: Viene eretto un nuovo altare maggiore a spese della famiglia Gentile, e il ciborio esistente viene trasportato nella cappella centrale del deambulatorio, dove rimane fino al 1844. 1743: a seguito di una scossa di terremoto crolla la cuspide del campanile, che dovette essere ricostruito qualche tempo dopo. | |
| Autore | La costruzione della chiesa romanica, corrispondente alla prima parte della navata odierna, si deve al protomagister Simiacca che in un atto del 1162, in cui figura come testimone, si definisce "protomagister frabice eclesie sancte Marie" (Codice Diplomatico Barlettano, I, doc. 93, 132-133). | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | Giovanni Pipino da Barletta (1307). Ferrante d'Aragona (1459; 1470). | |
| Descrizione | La chiesa ha un impianto a tre navate concluse da un deambulatorio radiale. Le prime quattro campate corrispondono alla vecchia chiesa romanica e sono separate da colonne; procedendo verso l'altare maggiore seguono due campate con volte a crociera su pilastri polistili, e quindi altre due campate a pianta trapezoidale che raccordano il corpo longitudinale più stretto alla più ampia abside traforata attonro alla quale corre lo stretto deambulatorio a cinque cappelle radiali. | |
| Iscrizioni | Sulla porta laterale sinistra della facciata è murato un blocco con iscrizione: "+ IMPENSIS RICHARDE TUIS / HEC PORTA NITEBIT / ERGO TIBI MlERITO / CELESTIS TELA PATEBIT". Sul fianco sinistro della chiesa compaiono diverse iscrizioni graffite. Una recita: "DEL GRAN CAP. IMP. NEL ANNO DEL S. 1503 FO LA GRAN VITTORIA". L'altra: "NEL ANNO 1528 FU SACHEGIATA ET DESTRUCTA BARLECTA PER LA DISCORDIA DELI CITADINI".
All'interno della chiesa. Sull'abaco di un capitello addossato al primo pilastro polistilo di sinistra: "MUSCATUS DEDIT IN IHS DUABUS COLUMNIS CC DUCALES QUI AS LEGIT ORET PRO EO /// ANNO MCLIII MENSE AUGUSTO. INDICTIONE PRIMA A DEO CAPTA EST SCALONIA". All'interno, nel presbiterio: "SEPUL. EGREGI FRA/NCISCI DE ROBERTO / MERCATORIS DE BA/RULO OBIIT AN.O / D.NI 1549 DE MESE / SEPTEMBER / ORATE PRO EO".
Nel pavimento del coro a destra: "HJERONIMO MAL/LIO ELETTO ARCHIPRE/SBITERO BAROLITA/NO QUEM IMMATURA / MORS NEAPOLI ERI / PUIT V. K. OCTOBRIS / 1555 MAGNIFICUS / CAMILLUS MAN/LEUS AR. ME. DOC. / PATER POSUIT / 1557 DIE / ULTIMO MARCII". A sinistra della precedente: "JOANNES DE LEO MAG. / V. I. D. MARIO DE LEO / MILITIQ. AURA FRATRI / CARISSIMO SIBIQ. HEREDIBUS / AC CONSANGUINEIS / SUIS POS. / MDLVIII". Sotto l'arcone sinistro del presbiterio: "MAG. JACOBUS BUCCUTUS SEPULCRUM SIBI AC SUIS / HEREDIBUS FACIENDUM MANDAVIT A PARTU VIRGINIS ANNO MDLX". Entro una lapide marmorea murata in un pilastro: "D. O. M. / BASILICAM HANC MAJORE INSIGNE COLLEGIATA MATRlCEM /DEO AC VIRGINI DEIPARAE IN COELU ASSUMPTAE / DICATAM / IN SOLO LATERANENSIS URBIS ET ORBIS MATRIS / FUNDATAM / EJUSQ. PRIVILEGIIS GRATIIS AC INDULGETIIS ONIBUS / AP.LICA LIB.RALITATE DITATAM / ILL.S ET REV.S D.NUS D. JOSEPH DAVANZATI S. T. D. PATRITIUS / FLORENTINUS EQUES .JEROSOLlIMITANUS DEI AP.LICAE SEDIS / GRATI A ARCHIEPISCOPUS TRANEN. ET SALPEN. AB.S S.TAE MARlAE DE / VICTORlA AC COES ET CATH. MAJESTATIS INTIMUS A LATERE / CONSILIARIUS SOLENI RITU SACRAVIT DlE XIII MARTII MDCCXXIX /EJUSQ. ANNIVERSARIU DEDICATIONIS AD DIEM XXIV NOV.BRlS TRAS/TULIT ONITIUSQ. CHRISTICOLIS EA VISITATITIUS XXXX DIES DE V. INDULG.COCES". Per terra innanzi al gradino del presbiterio: "PUBLICA DE RE RECTORIBUS / EXTREMO FATO FUNCTIS / NE CINERES INCULT, DEPEREANT / UTQUE PIACULARIBUS HOSTIIS JUV. VALEANT / STRATO TEMPLI PAVIMENTO / SENATUS BARULENSIS / SEPULCRUM DICAVIT A. MDCCCXXIII". Lungo le pareti laterali, nei pressi dell'altare maggiore, è oggi una lapide funeraria con testo scritto in latino e in tedesco: "HIC SEPULTUS GENERO / SUS DOMINUS CAROLS / COMES DE BARBI ET MI/LINGEN PROFECTUS IS/TIS PROVINCIIS CONTRA / TURCAM CUM GENERO/SO DOMINO JACOBO ANI/BALE COMITE IN EMPS / REGIS HISPANIARUM CO/SILIATORE ET TRIBUS / MILLIIS MILITUM GER/MANORUM TUTORE / QUI OBIIT / MENSIS AUGUSTI UN/DECIMA HORA / MDLXVI. / AETATIS SUAE ANNO / XXIII CUlUS / ANIMA IN DEO VIVAT / AMEN." | |
| Stemmi o emblemi araldici | Numerosi sono gli stemmi familiari apposti sui monumenti all'interno della chiesa. All'esterno, sul portale principale, è ripetuto più volte l'emblema della testa di cinghiale entro ghirlanda. Sulle murature esterne della Cappella di San Giuliano, sul lato destro della chiesa, è uno stemma con un'aquila e la data MCCCCLXXXXXI. | |
| Elementi antichi di reimpiego | All'esterno, alla destra dell'abside, sono collocate alcune colonne antiche in granito grigio. | |
| Opere d'arte medievali e moderne | Pulpito. Ciborio dell'altare maggiore. Cattedra episcopale. Tabernacolo eucaristico (sec. XVI). Ritratto di Ferrante d'Aragona. Tavola con Cristo alla colonna (sec. XV) Tavola lignea a doppia faccia (Vergine/Cristo). Paliotto d'altare rinascimentale a imitazione di sarcofago antico. | |
| Storia e trasformazioni | La chiesa insiste su una precedente basilica paleocristiana, a sua volta costruita al di sopra di un'area archeologica. L'edificio attuale è realizzato nel corso di tre diverse fasi costruttive: 1) metà XII secolo: costruzione della primitiva chiesa romanica a tre navate concluse da altrettante absidi. A parte le absidi, il resto della chiesa è ancora esistente. 2) fine XIII-inizio XIV secolo: costruzione della nuova abside con deambulatorio. 3) prima metà XVI secolo: costruzione delle campate intermedie fra la vecchia chiesa e l'abside gotica (Ambrosi 1984-1989, 68-70). | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | Pianta in Bruzelius 1999. | |
| Fonti/Documenti | 1307, 3 agosto. Bolla di papa Clemente V con cui si concede al nobile Giovanni Pipino da Barletta il permesso di ampliare e dilatare in maniera sontuosa la chiesa di Santa Maria, accordando anche cento giorni di indulgenza: “Clemens episcopus servus servo rum dei Universis christi fidelibus presentes licteras inspecturis, Salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam ut ait apostolus omnes stabimus ante tribunal christi, recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire, ac eternorum intuitu seminare in terris quod reddente domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eternam, Cum itaque dilectus filius nobilis vir Iohannes Pipinus de Barolo Miles, Magister Rationalis Curie Carissimi in christo fili i nostri Caroli Regis Sicilie lllustris sicut ipse nobis insinuare curavit, Maiorem ecclesiam sancte Marie eiusdem loci de Barolo Tranensis diocesis, ampliari et dilatari procuret opere sumptuose, ad cuius cosumationem operis fidelium suffragia sunt non modicum oportuna, universitatem vestram rogamus, et hortamur in domino, in remissione vobis peccaminum iniungentes, quatinus de bonis vobis a deo collatis pias ad hoc elemosinas, et grata caritatis subsidia erogetis ut per subventionem nostram, opus ipsum valeat consumari, vosque per hoc et alia bona que domino inspirante feceritis, ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad confirmationem dicti operis, manum porrexerint adiutricem, Centum dies, de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus, Presentibus post quinquaginta Annos minime valituris, quas mitti per questuarios districtius inhibemus eas si secus actum fuerit carere viribus decernentes. Datum Pictavis VII Idus Augusti Pontificatus nostri Anno Secundo" (da Codice Diplomatico Barlettano, I, 1924, doc. 131, pp. 320-321). Numerosi altri documenti sulla chiesa negli altri volumi del Codice Diplomatico Barlettano. | |
| Bibliografia | Ambrosi 1984-1989: Angelo Ambrosi, "Revival romanico e restauri stilistici in Terra di Bari tra XVI e XVII secolo", Ricerche sul Sei-Settecento in Puglia, 3, 1984-1989, 35-107. Ambrosi 2015: Angelo Ambrosi, Santa Maria Maggiore cattedrale di Barletta (XII-XVI sec.). L’architettura, Bari 2015. Barletta 2000: Dalla chiesa alla “civitas”. Nuove acquisizioni dagli scavi archeologici nella Cattedrale di Barletta, Atti dell’Incontro di Studi (Barletta, 15 marzo 1997), Barletta 2000.
Bertaux 1904: Emile Bertaux, L'art dans l'Italie méridionale, de la fin de l'Empire romain à la Conquête de Charles d'Anjou, Paris 1904, 359-360.
Bruzelius 1999: Caroline Bruzelius, "A torchlight procession of one. Le choeur de Santa Maria Maggiore de Barletta", Revue de l'Art, 125, 1999, 9-19.
Bruzelius 2005: Caroline Bruzelius, Le pietre di Napoli, L'architettura religiosa nell'Italia angioina (1266-1343), Roma 2005, 185-189.
Codice Diplomatico Barlettano, a cura di Salvatore Santeramo, 4 voll., Barletta 1924-1962.
De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Iorio 2005: Raffaele Iorio, "Ecclesia e Civitas barlettane nei documenti medievali”, Archivio Storico Pugliese, 58, 2005, 157-278. Enlart 1894: Camille Enlart, Origines française de l’architecture Gothique en Italie, Paris 1894, 206-208. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Pace 2005: Valentino Pace, “Echi della Terrasanta: Barletta e l’Oriente crociato”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 393-408.
Rivera Magos 2009: Victor Rivera Magos, "Rapporti di potere a Barletta tra età sveva e primo angioina (1232 – 1282)”, Archivio Storico Pugliese, 63, 2009, 43-111.
Russo 2001: Renato Russo, Santa Maria Maggiore, la cattedrale di Barletta: profilo storico-architettonico, Barletta 2001. Santeramo 1917: Salvatore Santeramo, Il simbolismo della Cattedrale di Barletta, Barletta 1917. Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. Testini 1986: Maria Pia Testini, "Fanzago nella cattedrale di Barletta”, Napoli nobilissima, s. 3, 25, 1986, 101-106. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 48-85. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 04/11/2013 10:25:55 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 11:02:12 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/574 |
| Oggetto | Barletta, fognatura | |
|---|---|---|
| Tipologia | infrastruttura | |
| Nome attuale | (distrutto) | |
| Immagine | ||
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1274-1275: nel maggio del 1274 Carlo I dà facoltà all’università di Barletta di imporre una gabella sul grano per sostenere le spese necessarie al miglioramento dei canali di scolo. Tre mesi dopo la raccolta del denaro doveva essere già conclusa, e il sovrano incarica Galgano Sannella della pulitura dei canali. I lavori risultano ancora in corso nel settembre dell’anno successivo (Rivera Magos 2009, 85). Da quanto scritto nei documenti sembra potersi ricavare che la città fosse già dotata si un sistema di canali di scolo, di cui viene ordinato il miglioramento e la pulizia. 1300: il 24 ottobre del 1300 Carlo II emana un provvedimento per la manutenzione delle mura, l’allargamento delle strade e la risistemazione complessiva del sistema fognario della città di Barletta (Loffredo 1893, I, 309; II, 327-335, doc. XXIX). | |
| Autore | L'appaltatore dei lavori del 1274 è il maestro Galgano Sannella. | |
| Committente | Carlo I d'Angiò Carlo II d'Angiò | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | Non è nota la conformazione e l'estensione della rete di canali di scolo che attraversava la città di Barletta in età angioina. Dai documenti relativi ai lavori del 1274 apprendiamo che erano in corso lavori di ampliamento al canale che scorreva sotto la Platea Veteri. Il rescritto di Carlo II del 1300 fornisce alcune indicazioni in più. Il sovrano ordinava la costruzione di un sistema composto da canali principali, che dovevano scorrere sotto le strade pubbliche principali e scaricare a mare, ai quali si sarebbe dovuta innestare una rete di canali minori. I collettori principali dovevano essere costruiti come gallerie in muratura, con pavimento e murature in pietra e copertura a volta ("...fiant in omnibus viis puplicis magnarum stratarum terre predicte [Baroli] canalia proclivia funditu et fluxilia versu mare que quidem sternantur in fundo lapidibus et habeant lapidea latera et sint ad lamiam sive voltam lapidum cohoperta ita iunctis lapidibus quod nulla in superficie dictorum canalium scissura vel rimula remaneat"). Questi canali dovevano avere una altezza interna di dieci palmi e una larghezza di quattro. I canali minori "quod in ipsa magna canalia defluant", alti quattro palmi e larghi tre, non dovevano essere coperti a volta ma "ad iunctas plancas lapideas", ovvero con semplici lastre di pietra, murate in modo da non lasciare "aliquo foramine vel scissura". Il percorso del collettore principale si può dedurre dalla precisazione che si provvedesse alla realizzazione di pozzi necessari alla pulizia dei canali, nel tratto compreso fra la porta Sancti Sepulcri e la Ecclesiam Sancte Marie de Nazareth. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | I provvedimenti emanati nel 1274 da Carlo I sono nel volume XI della Ricostruzione Angioina, 143, 152, 229, docc. 259 (5 maggio 1274), 166 (2 giugno 1274), 312 (31 agosto 1274). Il rescritto di Carlo II del 1300 è pubblicato in Loffredo 1893, II, 327-335, doc. XXIX. | |
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893.
Rivera Magos 2009: Victor Rivera Magos, "Rapporti di potere a Barletta tra età sveva e primo angioina (1232 – 1282)”, Archivio Storico Pugliese, 63, 2009, 43-111. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 09/01/2014 14:34:29 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:14:25 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/636 |
| Oggetto | Barletta, mura | |
|---|---|---|
| Tipologia | mura urbiche | |
| Nome attuale | mura | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | XI secolo: costruzione della cinta muraria a opera del conte Pietro il Normanno. 1156-1162: primo ampliamento della cinta muraria, che si estende a inglobare anche la chiesa del Santo Sepolcro, prima extra moenia. 1268: Carlo I d'Angiò amplia nuovamente il circuito urbano, rifacendo la cortina meridionale delle mura. 1295: Carlo II d’Angiò ordina il completamento delle mura, con la chiusura dell'intera città. 1300: nuovi provvedimenti per le mura di Barletta, di cui viene definito il tracciato. Il progetto viene iniziato ma in misura ridimensionata. 1458-1481: negli statuti cittadini del 1458, del 1465 e del 1481 si fa costante riferimento alle mura, ai fortilizi e ai fossati della città, la cui manutenzione è a carico dei cittadini di Barletta. 1514-19: si realizza l'ampliamento della cinta muraria, su progetto di Antonello da Trani, per inglobare il borgo e la chiesa di San Giacomo. 1521: si dà avvio a una nuova murazione per includere il borgo di San Vitale. 1528: i borghi esterni alle mura vengono distrutti, e con essi anche il nuovo tratto di mura destinato a includere nella città di borgo di San Vitale, che non viene più ricostruito. 1840: apertura di una nuova porta. 1860: abbattimento. | |
| Autore | Antonello da Trani (1514-1519) | |
| Committente | Pietro il Normanno Carlo I d'Angiò Carlo II d'Angiò Universitas di Barletta | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Le mura di età normanna racchiudevano soltanto il nucleo urbano raggruppato intorno alla cattedrale. Una porta si apriva più o meno in corrispondenza dell'attuale palazzo Bonelli: sarebbe stato qui che, secondo la leggenda, Roberto signore di Barletta, dopo aver sconfitto o saraceni, avrebbe pulito la sua mano sporca di sangue su uno stipite bianco, dando così origine allo stemma della città (Vista 1900-1904, I, 5). Da qui il nome di Gloria al quartiere e allo stesso palazzo Bonelli già d'Iserio. La porta sarebbe poi divenuta inutile dopo il primo ampliamento a metà XII secolo, quando veniva spostata in corrispondenza della chiesa del Santo Sepolcro. Un secondo ampliamento è promosso in età angioina, mentre altri si verificano tra la fine del '400 e l'inizio del '500. In particolare, fra il 1514 e il 1519 l'architetto Antonello da Trani realizza l'ampliamento che cominciando da Porta Reale e proseguendo verso Sant'Agostino raggiungono la Porta del Santo Sepolcro (Ceci 1930, 59): è in questo tratto murario che viene aperta la Porta Nuova o di San Sebastiano (Loffredo 1893, II, pp. 62-63). L'unica porta urbica ancora esistente è Porta Marina. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | Il perimetro della cinta muraria è riprodotto in una serie di piante militari tardocinquecentesche e seicentesche: Firenze, Uffizi 4285A (Brunetti 2006, 53); Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XII.D.69, cc. 4v-5r; Parigi, Bibliothèque Nationale, Royaume de Sicile, VI, Pr. de Bari, P. 61929 (Brunetti 2006, 55); Roma, Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, rilievo delle fortificazioni della città (attr. a Tiburzio Spannocchi; riprodotto in Brunetti 2006, 57); Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. VI, 188.
A fine XVIII secolo le mura sono raffigurate anche in: | |
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | 1514-1519: Archivio Comunale di Barletta, Conclusioni dell'Università di Barletta, 1514-1515, 1521-1522 (cit. da Ceci 1930, 59, nota 3). | |
| Bibliografia | Brunetti 2006: Oronzo Brunetti, L’ingegno delle mura. L’Atlante Lemos della Bibliothèque Nationale de France, Firenze 2006, 55-58.
Ceci 1930: Giuseppe Ceci, “Un dimenticato ingegnere militare pugliese del secolo XVI: Antonello da Trani”, Japigia, 1930, 54-60. Faraglia 1883: Nunzio Federico Faraglia, Il comune nell’Italia meridionale, Napoli 1883.
Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 7-9. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 10:08:17 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:18:49 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/609 |
| Oggetto | Barletta, ospedale dei Cavalieri di Malta | |
|---|---|---|
| Tipologia | ospedale | |
| Nome attuale | residenza privata | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Domus ospitaliera | |
| Cronologia | ||
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | L'ospedale, oggi si trova nei pressi del complesso conventuale di Santa Chiara (profondamente trasformato) ma in origine era una delle residenze cittadine dell'Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta che avevano in Barletta uno dei priorati del Regno. Recentemente restaurata, oggi è una residenza privata e conserva dell'aspetto originario, attribuibile al sec. XV, il paramento in grandi blocchi di calcare e le porte d'ingresso, tra cui le due laterali con archi acuti e quella più ampia, centrale, a tutto sesto. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | L'edificio, sorto a ridosso del centro antico su una delle principali strade di attraversamento e collegamento cittadino (Strada del Cambio, odierno Corso Cavour) nei pressi di due complessi ecclesiastici importanti (le chiese conventuali di S. Chiara e S. Lucia) era una delle sedi dislocate in città dell'Ordine Ospitaliero Gerosolomitano che aveva in Barletta uno dei priorati del Regno. Dell'antico assetto si conserva solo il prospetto del pianterreno, recentemente restaurato. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Carabellese 1898: Francesco Carabellese, “L’Ordine di Gerusalemme in Puglia sotto i re normanni e svevi”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 15, 1898, 2-6.
Fiorella 2005: Danila Fiorella, “La presenza degli Ordini monastico-cavallereschi a Barletta”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 409-434. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Antonio Milone | |
| Data di compilazione | 02/02/2014 15:05:26 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:51:27 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/664 |
| Oggetto | Barletta, ospedale del Santo Sepolcro | |
|---|---|---|
| Tipologia | ospedale | |
| Nome attuale | Ospedale del Santo Sepolcro | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Ospedale dei Pellegrini | |
| Cronologia | 1580: donazione di una rendita da parte di fra Ettore Marulli per il mantenimento della struttura. 1834: restauro della struttura. 1888: trasformazione in civili abitazioni. | |
| Autore | ||
| Committente | Ettore Marulli lascia una rendita per la struttura (1580). | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | L'ospedale, compreso nell'isolato della chiesa del Santo Sepolcro, presenta una semplice facciata arricchita da una iscrizione che ricorda un restauro nel 1834. | |
| Iscrizioni | iscrizione sul portale: "HOCCE QUOD SPECTAS HOSPITIUM/ SOLUMMODO/ PERDITA VALETUDINIS EGENIS/ ADVENIS INDIGENIS QUE/ VELUT AEGRAE HUMANITATIS/ PERFUGIUM/ DICATUM/ OB/ EIUSDEM ADMINISTRATORUM SOLERTIAM/ IN MELIUS ADAUCTUM/ ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCCCXXXIV". | |
| Stemmi o emblemi araldici | Stemma sull'iscrizione. | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | L'edificio, sorto nel medioevo contestualmente alla chiesa del Santo Sepolcro quale luogo di ospitalità per pellegrini, ha subito numerosi rifacimenti e modifiche fino all'alienazione del sec. XIX. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Carabellese 1898: Francesco Carabellese, “L’Ordine di Gerusalemme in Puglia sotto i re normanni e svevi”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 15, 1898, 2-6.
De Leone 1888: Filippo De Leone, “Per Barletta. Passeggiata storico-artistica”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 347-348.
Fiorella 2005: Danila Fiorella, “La presenza degli Ordini monastico-cavallereschi a Barletta”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 409-434. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Antonio Milone | |
| Data di compilazione | 02/02/2014 15:02:11 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:52:50 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/663 |
| Oggetto | Barletta, Palazzo Affaitati | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo | |
| Nome attuale | ||
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Palazzo Samuelli, Palazzo Affaitati. | |
| Cronologia | XVI secolo: edificazione. 1754: si estingue la famiglia Samuelli che fino ad allora aveva posseduto il palazzo. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | Famiglia Samuelli. Famiglia Affaitati. | |
| Descrizione | Il palazzo, su tre piani fuori terra e con un'ampiezza di cinque campate, presenta una cortina esterna in bugnato, con bugne rustiche al piano terreno, e a punta di diamante ai due piani superiori; quest'ultima è però interrotta nelle tre campate centrale da un'interpolazione ottocentesca. Al piano terreno si apre il portale, con cornice centinata riccamente decorata, inquadrata da paraste corinzie scanalate che sorreggono una trabeazione dal fregio a rilievi, e raffigurazioni di vittorie alate nei pennacchi. Oltre il portone si sviluppa un atrio monumentale concluso verso il cortile da un grande arco con intradosso a cassettoni. In fondo al piccolo cortile si sviluppa uno scalone aperto settecentesco. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note |
| |
| Fonti iconografiche | Pianta Esperti 1793, n. 88. | |
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350.
Gelao 1988: Clara Gelao, "Palazzi con bugnato a punta di diamante in terra di Bari", Napoli Nobilissima, s. 4, 27,1988, 12-28. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 10/01/2014 16:48:16 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:55:20 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/638 |
| Oggetto | Barletta, Palazzo Bonelli | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo | |
| Nome attuale | Palazzo Bonelli | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Palazzo Della Marra | |
| Cronologia | 1324: Guala de Yserio costruisce il palazzo. 1326: Guala de Yserio sposa Adolisia Della Marra, figlia di Jacopo e alla sua morte senza eredi il palazzo passa ai Della Marra. 1685: Palazzo acquistato dalla famiglia Bonelli. 1902 circa: il portico rischia di essere demolito secondo quanto previsto dal Piano regolatore cittadino ma l'intervento del Direttore Generale dell'Ufficio Regionale, Adolfo Avena, sventa il pericolo. | |
| Autore | ||
| Committente | Guala de Yserio (1324) | |
| Famiglie e persone | Della Marra, proprietari dell'edificio dal sec. XIV al 1685. Bonelli, proprietari dell'edificio a partire dal 1685. | |
| Descrizione | Il palazzo sorge nel pieno centro storico, lungo l'asse di corso Garibaldi quasi all'incrocio con via Cialdini, a ridosso dell'insediamento più antico della città, sorto nei pressi della chiesa maggiore di Santa Maria. L'edificio risale al sec. XIV e della primitiva edificazione conserva l'impianto complessivo e il bel porticato con archi acuti e volte a crociera che segue il prospetto principale e un fianco (con le aperture murate). Nei piani superiori, il prospetto è abbellito dal bugnato piatto quattrocentesco a filari regolari dei livelli superiori, che parte dalla cornice marcapiano che chiude le arcate del portico ed è coronato da un cornicione modanato. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | L'edificio che sorge nel cuore del centro antico fu costruito nella prima metà del sec. XIV e a questa fase costruttiva risale il lungo porticato del pianterreno; interventi successivi modificarono l'assetto esterno, con il bugnato a filari regolari dei livelli superiori che parte dalla cornice marcapiano che chiude le arcate del portico ed è coronato da un cornicione modanato. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | Pianta Esperti 1793, al numero 64. | |
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Avena 1902: Adolfo Avena, Monumenti dell’Italia meridionale, Roma 1902, 54-55.
Derosa 2014: Luisa Derosa, “I luoghi dei Della Marra: Palazzo Bonelli”, in Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel medioevo, a cura di Victor Rivera Magos, Bari 2014, 121-154.
Mongiello et alii 2012: Giovanni Mongiello, Domenico Spinelli, Cesare Verdoscia, Le architetture aragonesi e spagnole in Puglia. Materiali per la costituzione di un repertorio dei caratteri stilistici degli edifici del primo Rinascimento, Bari 2012, 36-37. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Antonio Milone | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 09:53:48 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:57:24 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/608 |
| Oggetto | Barletta, Palazzo dell'Arco | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo pubblico | |
| Nome attuale | (distrutto) | |
| Immagine |   | |
| Nomi antichi | Palazzo dell'Arco Petorio, Palazzo del Capitano, convento dell'Annunziata | |
| Cronologia | 1473: il palazzo è costruito dallo spagnolo Francesco de Arenis (Loffredo 1893, I, 427; cfr. infra, Iscrizioni). 1491: il palazzo è citato negli statuti come sede del Capitano. 1528: adibito a monastero per le monache dell’Annunziata (la sede dell'universitas passa al palazzo Pretorio). | |
| Autore | ||
| Committente | Francesco de Arenis (m. 1484), giustiziere di Terra di Bari. | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | Un tempo era l'iscrizione (oggi scomparsa): "FRANCISCUS DE HARENA / HISPANUS / VIR LITTERIS ET RERUM GESTARUM GLORIA INSIGNIS / PRAETORIUM EXTRUIT EX RESIDUIS VECTIGALIUM / CUM GERERET IN HAC URBE PRAETURAM / REGNANTE FERDINANDO INCLITO NEAPOLITANO REGE / A. GEN. SAL. 1473" (Vista 1900-1904, III, 4). | |
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Nei pressi del palazzo era la vecchia "porta della Città", divenuta inutile con l'ampliamento delle mura e l'inglobamento nel circuito urbano del borgo di San Giacomo (Loffredo 1893, II, 67). | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, III, 3-17. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 10/01/2014 20:31:04 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:00:30 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/640 |
| Oggetto | Barletta, Palazzo Della Marra | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo | |
| Nome attuale | Pinacoteca De Nittis | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Palazzo Orsini | |
| Cronologia | 1582: il palazzo appartiene a Lelio Orsini, conte di Pacentro, Tagliacozzo e Oppido. 1591-1596: Lelio Orsini intraprende il restauro del palazzo. I numerosi documenti pubblicati nel Codice Diplomatico Barlettano consentono di precisare che risale a questi anni la realizzazione della loggia "da la parte de dietro la ditta casa verso la marina" decorata con "frisi, cornicioni, balaustri et pilastrelli con teste de imperatori de mezo rilievo da la banda de fuori, et arme et trofei seu altre teste da la banda de dentro". Il progetto prevedeva anche un rivestimento esterno in bugne a punta di diamante "conforme quello de lo domino Francesco Affatatis de Barolo" (Palazzo Affaitati): caratteristica che invece il palazzo odierno non presenta. Scomparsi sono anche gli affreschi commissionati ai pittori Alessandro Fracanzano e Giacomo Russo. 1633: venduto alla famiglia Della Marra. Risale a una data probabilmente immediatamente successiva la realizzazione dell'opulento aparato decorativo del balcone collocato sopra il portale principale del palazzo. 1650: la loggia sul cortile è decorata con dipinti raffiguranti le Quattro stagioni. | |
| Autore | ||
| Committente | Lelio Orsini | |
| Famiglie e persone | Orsini Della Marra | |
| Descrizione | Il palazzo si sviluppa come un corpo compatto a tre piani fuori terra, con basamento a bugne rustiche, organizzato intorno a un cortile centrale. Sul retro si sviluppa un giardino e al piano nobile una ampia loggia affacciata sul mare. | |
| Iscrizioni | Nel fregio della facciata sono le lettere "DELLA / MARRA". | |
| Stemmi o emblemi araldici | Stemma Della Marra in facciata, fra le due finestre centrali del piano nobile. | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | Pianta in Gelao 2005, 225. | |
| Fonti/Documenti | I documenti relativi alla costruzione del palazzo fra il 1591 e il 1596 sono pubblicati nel Codice Diplomatico Barlettano 1994: XI, 162; XII, 31, 48, 60, 138, 201, 250, 269, 345, 358, 359, 372, 373). | |
| Bibliografia | Codice Diplomatico Barlettano 1994: Codice Diplomatico Barlettano, voll. XI-XII, a cura di Salvatore Santeramo, Carlo Ettore Borgia, Bari 1994.
Gelao 2005: Clara Gelao, “Il palazzo Della Marra a Barletta", in Clara Gelao, Puglia rinascimentale, Milano 2005, 218-225.
Santeramo 1923: Salvatore Santeramo, Il palazzo della Marra, Barletta 1923.
Sarlo 1892: Francesco Sarlo, "La nobile famiglia della Marra ed il suo palazzo in Barletta", Arte e Storia, 11, 1892, 26-27.
Villani 2007: Maria Pia Villani, Il Palazzo Della Marra a Barletta, Bari 2007. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 13/01/2014 10:33:42 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:02:58 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/644 |
| Oggetto | Barletta, Palazzo Pretorio | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo pubblico | |
| Nome attuale | municipio | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1528: dopo la cessione del palazzo del Capitano alle monache dell'Annunziata, la città rimane priva di un palazzo per le proprie adunanze. Palazzo Pretorio diventa la nuova sede dei principali uffici dell'Universitas di Barletta. 1540: data di costruzione del nuovo Palazzo Pretorio (cfr. infra, Iscrizioni). 1769: palazzo caduto in rovina, l’Universitas si riunisce nella chiesa di Sant’Antonio Abate al Paniere del Sabato (attuale Piazza Plebiscito). 1785: si decide la ricostruzione del palazzo. | |
| Autore | ||
| Committente | Universitas di Barletta | |
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | Due iscrizioni adesso perdute e attestanti lavori eseguiti alla metà del XVI secolo sono trascritte da De Leon e poi pubblicate da Loffredo (1893, II, 67, nota 23) e da Vista (1900-1904, IV, 88): "SUB DIVO CAROLO V ROMANORUM IMPERATOR / RESPUBLICA BARULITANA / PRESIDENTE MAG. ANTONIO DALDANO PRAETORE CONSTRUXIT A. 1540”. "FIDELISSIMA RESPUBLICA BARULITANA / A MAGNIF. FERDINANDO FIGUERA V. J. D. REG. CAPITANEO / ET COMMISSARIO REDEMPTIONIS IPSE ADHIBUIT ERE ALIENO / GRAVATA REDIMENTO JUSTAQUE PROVENTA FACIENDO / ET EX EO EDIFICIUM ISTUD PRO EDIS ET ASCENTIUM COMMODITATE PERFECIT A. D. 1548”. | |
| Stemmi o emblemi araldici | Secondo De Leon (cit. in Loffredo 1893, II, 67, nota 23; Vista 1900-1904, III, 8; IV, 87) sul palazzo era un’arma aragonese con la data 1512, che secondo Loffredo era stata qui trasportata dal vecchio palazzo. | |
| Elementi antichi di reimpiego | All'angolo sinistro della facciata è posizionato il cippo in pietra con campo epigrafico ormai totalmente abraso. Potrebbe trattarsi della iscrizione CIL, IX, 318, che Seccia 1842, 6 dice "trasportata in Barletta in aprile 1839" e Mommsen 1883, 34 precisa trovarsi "ante curiam". | |
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), II, 67. Mommsen 1883: Theodor Mommsen, "Cannae", in Corpus Inscriptionum Latinarum, IX, Berolini 1883, 34. Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, IV, 85-97. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 12/01/2014 16:59:19 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:06:24 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/641 |
| Oggetto | Barletta, Palazzo Santacroce | |
|---|---|---|
| Tipologia | palazzo | |
| Nome attuale | Palazzo Santacroce | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1780: acquisizione del palazzo da parte della famiglia Santacroce. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | Famiglia Queralt Famiglia Santacroce | |
| Descrizione | L'edificio, posto nella piazza antistante la chiesa matrice di S. Maria, ne occupa parte del sagrato e si sviluppa ad angolo affacciandosi verso la vicina chiesa rinascimentale di San Pietro. Il palazzo, di grandi dimensioni, risale al sec. XV, come rivela il pianterreno che presenta due portali ad arco acuto (dei tre originali), riquadrati da una cornice a toro sottile, secondo una tipologia diffusa in tutto il Regno. Il paramento è in conci squadrati lisci di medie dimensioni e ben connessi e gli ingressi sono l'elemento più caratterizzante, con il sesto ben definito e le cornici lisce a piccole bugne di diamante (quello laterale di destra ora è murato). Una netta cornice marcapiano segna la base dei piani superiori, con il paramento intonacato con paraste giganti e balconi che rivelano interventi seriori, databili al tardo Settecento, come indica anche il timpano neoclassico centrale. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Il palazzo, sorto in pieno centro storico nei pressi della cattedrale, ha un impianto risalente al sec. XV, con interventi di radicale rifacimento nei piani superiori databili al sec. XVIII, probabilmente in concomitanza con il passaggio dalla famiglia Queralt alla famiglia Santacroce. Altre modifiche successive si notano nella parte sinistra della facciata, risalente ai secc. XIX-XX. | |
| Note |
| |
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | Pianta Esperti 1793, al numero 74. | |
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Barone 2011-2012: Maria Teresa Barone, Elementi morfologici dell’architettura rinascimentale in terra di Bari. Il caso del palazzo Sylos Calò a Bitonto, tesi di dottorato (tutor Francesco Paolo Fiore), dottorato di ricerca in Storia e restauro dell’architettura, Università di Roma “La Sapienza”, a.a. 2011-2012.
Borgia 1989: C. E. Borgia, La città di Barletta e il suo territorio, Barletta 1989.
Carbonara 1983-1984: G. Carbonara, Sviluppo urbano ed edilizia civile a Barletta dal XVI al XVII secolo, tesi di laurea, Università degli studi di Bari, a.a. 1983-1984.
Mongiello et alii 2012: Giovanni Mongiello, Domenico Spinelli, Cesare Verdoscia, Le architetture aragonesi e spagnole in Puglia. Materiali per la costituzione di un repertorio dei caratteri stilistici degli edifici del primo Rinascimento, Bari 2012, 32-33.
Russo 2005: R. Russo, Barletta. Immagini di ieri e di oggi, Barletta 2005. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Antonio Milone | |
| Data di compilazione | 10/01/2014 16:53:06 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:09:56 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/639 |
| Oggetto | Barletta, Porta Marina | |
|---|---|---|
| Tipologia | Porta urbica | |
| Nome attuale | Porta Marina | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1751 | |
| Autore | ||
| Committente | Universitas di Barletta | |
| Famiglie e persone | Carlo III di Borbone Saverio Fraggiani (sindaco) Giuseppe De Elia (eletto) Vincenzo Stefanelli (eletto) | |
| Descrizione | La porta, un tempo inserita al centro delle mura, si trova oggi isolata come edificio autonomo. Presenta uno stemma nel prospetto verso la città, e una iscrizione in quello rivolto verso il porto. | |
| Iscrizioni | "D.O.M. / CAROLO PIO FEL. AUG. REGNANTE / QUA PORTUM RECTA ADIRI LICEAT / ORDO POPULUSQ. BAROLITANUS / ELEGANTIOREM PORTAM PATEFECIT A. MDCCLI / MARCHIONE XAVERIO FRAGGIANNI SINDICO / JOSEPHO DE ELIA ET VINCENTIO STEPHANELLI ELECTIS". | |
| Stemmi o emblemi araldici | Sul prospetto verso la città è il grande stemma reale con ai piedi due stemmi replicati della città di Barletta. Altri due stemmi della città sono anche ai lati della grande iscrizione apposta sul fronte verso il porto. | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, V, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 10:09:22 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:11:47 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/610 |
| Oggetto | Barletta, Porto | |
|---|---|---|
| Tipologia | porto | |
| Nome attuale | porto | |
| Immagine |   | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | II-IV sec. d.C.: Costruzione. Pontano (De Bello Neapolitano, lib. IV) lo riteneva costruito da Eraclio (cfr. Loffredo 1893, I, 2). Alle fine del XVIII secolo erano ancora visibili tratti di grossi muri, che Mola 1796, 6-9 identificava come moli antichi. 1253-54 ca.: Corrado IV intorno al 1253-54 ne prevede il rifacimento a spese della corona, come già previsto da Federico II (Rivera Magos 2009, 55, nota 44). 1300: ricostruzione a opera di Carlo II d'Angiò (Loffredo 1893, II, 323-335). 1458: provvedimenti in merito al porto si ritrovano nei capitoli concessi alla città; da questo momento è certo che gli oneri per il mantenimento ricadono sulla città. 1465: nei nuovi capitoli della città altri interventi per il porto. 1481: ancora altri provvedimenti negli altri capitoli della città di Barletta. 1750: nuovi lavori promossi dal marchese Nicolò Fragianni. 1807: costruzione del faro. 1852: lavori di ammodernamento. 1880-1889: costruzione del nuovo porto. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | La costruzione del porto sarebbe contestuale alla stessa nascita della città. Un nuovo molo viene costruito fra il II e IV secolo d.C. come sbocco portuale della vicina città di Canosa. Nel periodo svevo e poi angioino il mantenimento è della corona, ma sotto gli aragonesi l'onere passa alla città. | |
| Note | Vista 1900-1904, I, 39-40, ricorda la presenza sul molo del porto di "un gran termine di pietra bianca", chiamato "la mamma d'Aré" e ipotizza che tale nome possa essere derivato dalla presenza in quel luogo della statua del Colosso, poi trasportato all'interno della città all'ingresso del Seggio del Popolo. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | Documento di Carlo IV del 1254 trascritto parzialmente in Rivera Magos 2009; documenti di Carlo II d'Angiò del 1300 trascritti integralmente in Loffredo 1893. | |
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).
Miroslav Marin 1991: Meluta Miroslav Marin, “I problemi topografici di Barletta antica”, Archivio Storico Pugliese, 1991, 7-47.
Mola 1796: Emmanuele Mola, Peregrinazione letteraria per una parte dell’Apulia, con la descrizione delle sue sopravvanzanti antichità, dell'avvocato e prefetto de' regi studi e delle antichità dell' Apulia medesima, Bari 1796. Rivera Magos 2009: Victor Rivera Magos, "Rapporti di potere a Barletta tra età sveva e primo angioina (1232 – 1282)”, Archivio Storico Pugliese, 63, 2009, 43-111.
Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 85-102. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 09/01/2014 17:58:23 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:12:52 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/637 |
| Oggetto | Barletta, San Domenico | |
|---|---|---|
| Tipologia | Chiesa e complesso monastico | |
| Nome attuale | San Domenico | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Santa Maria Maddalena, San Domenico | |
| Cronologia | 1528: la chiesa viene ceduta ai domenicani. 1683: riedificata. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | ||
| Iscrizioni | "D. O. M. / NOBILISSIMA BARVLI PlETAS MIRACVLV / HOC PAVPERTATIS EREXIT NE MIRERIS SIN. / MAGNIFICV PENITENTI COLITVR OSPITI / VM HOC ANTRVM DEDIT MAGDALENAE HOS / ADlVNXIT DOMINICO AB OMNIBVS LAVD. / AB VTROQ. GRATIAS AB VNO GLORIA / VIATOR EXPECTAT VALE / A. D. MDCLXXXIII". | |
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | La chiesa era la sede della assemblee dell'Universitas di Barletta. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/02/2014 15:15:44 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:15:59 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/667 |
| Oggetto | Barletta, San Giacomo | |
|---|---|---|
| Tipologia | chiesa | |
| Nome attuale | San Giacomo | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1083, post: probabile fondazione della chiesa e del borgo annesso, dove si rifugiano i profughi della distrutta città di Canne. 1158: papa Adriano IV cita la chiesa di San Giacomo "cum hospitio extra portas Baruli" come appartenente ai benedettini di Monte Sant'Angelo (Loffredo 1893, II, doc. X, 280-283). 1205: diploma di Federico II, dal quale risulta che la chiesa è ancora possessione dell'abate di Monte Sant'Angelo (Loffredo 1893, II, doc. XI, pp. 284-285). 1514: costruzione della cappella a destra del presbiterio. 1514-1519: il borgo di San Giacomo viene incluso nel nuovo ampliamento delle mura. 1726: interventi di restauro. 1841: costruzione dell'obelisco posto al centro della facciata sulla strada, e della torre con l'orologio posta di fronte. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | La chiesa è collocata parallelamente alla strada, cui offre il fianco sinistro: la facciata originaria è ormai completamente inglobata in edifici successivi. L'accesso avviene quindi lateralmente in un avancorpo aggettante: nello spazio fra l'avancorpo di ingresso e il transetto si trovano alcune botteghe, di cui la centrale sormontata da un obelisco. L'interno è strutturato come un invaso a pianta latina, ad aula unica, concluso da un transetto su cui si aprono tre cappelle. La copertura è a capriate lignee, e una serie di cappelle di epoca e forma diseguali si aprono sul finaco destro. | |
| Iscrizioni | Sull'arco della cappella a destra del presbiterio: "HANC CAPPELLAM / FIERI FECIT RADICHYO / DE LACETIGNOLA / 1514". | |
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | Monumento funebre medievale: secondo Vista 1900-1904, 77-78 ospiterebbe le spoglie dei vescovi di cannesi Guglielmo (+ 1155), Pasquale (+ 1199) e Riccardo Galimberti (+1439). In sagrestia sono custodite: una predella del XV secolo attribuita a Tuccio d'Andria; una pala a fondo oro dipinta su entrambi i lati con raffigurazioni della Vergine e del Cristo. | |
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | A differenza del vecchio nucleo urbano della città, raccolto intorno alla Cattedrale e afferente alla giurisdizione del vescovo di Trani, il borgo e la chiesa di San Giacomo appartenevano alla diocesi di Canne. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, II, 62-89. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 09:44:37 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:17:46 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/606 |
| Oggetto | Barletta, Sant'Andrea | |
|---|---|---|
| Tipologia | chiesa | |
| Nome attuale | Sant'Andrea | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | San Salvatore, Sant'Andrea | |
| Cronologia | 1180: primo documento che cita la chiesa di San Salvatore in Barletta (Vista 1900-1904, III, 19). 1528: in previsione di un pericoloso assedio della città, si decide di spianare i borghi esterni alle mura, e con essi numerose chiese e conventi. Fra essi anche la chiesa francescana di Sant'Andrea. 1532: i Della Marra cedono la chiesa del Salvatore ai francescani, che cominciano a edificare il convento e ne mutano il nome in Sant'Andrea. XVI secolo, seconda metà: la chiesa viene ampliata con la costruzione del cappellone e delle cappelle laterali. 1592: la chiesa viene nuovamente consacrata dall'arcivescovo di Nazareth, Girolamo Bevilacqua. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | La chiesa è stata per molto tempo patronato privato della famiglia Della Marra. All'interno cappelle e sepolture delle famiglie Fraggianni, Ambrosi, de Annis, Marulli, Vultabio, Campanile, Cicala, de Gerardis detti Salmegia, Kerbes, Queraldi, Bonelli. | |
| Descrizione | La chiesa, preceduta da alta scalinata, presenta un prospetto interamente in pietra con al centro i resti dell'antico portale romanico. All'interno si sviluppa a pianta longitudinale, con tre navate suddivise da pilastri quadrangolari e presbiterio quadrato. La porzione anteriore della navata principale è coperta con capriate, mentre le navate laterali, le campate finali della navata centrale e il presbiterio sono voltati. | |
| Iscrizioni | Sull'architrave dle portale maggiore: INCOLA TRANENSIS SCULPSIT SIMEON RAGUSEUS DNE MISERE | |
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | Fra le opere d'arte presenti nella chiesa le principali sono le sculture del portale romanico, la pala d'altare di Alvise Vivarini, firmata e datata 1483, una tavola, raffigurante il santo eponimo, anch'essa attribuita al Vivarini, due statue marmoree cinquecentesche raffiguranti rispettivamente San Michele Arcangelo e San Giovanni Battista, un rilievo con l'Annunciazione (XVI secolo), questi ultimi attribuiti alla società Caccavello-D'Auria. | |
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), II, 70-72. Naldi 2004: Riccardo Naldi, “Scultura del Cinquecento in Puglia: arrivi da Napoli”, in Scultura del Rinascimento in Puglia, Atti del Convegno Internazionale (Bitonto, palazzo Municipale, 21-22 marzo 2001), Bari 2004, 161-186. Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 140-141. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, III, 19-56. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 09:46:16 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:24:47 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/607 |
| Oggetto | Barletta, Santa Chiara | |
|---|---|---|
| Tipologia | chiesa (esistente) con annesso convento (trasformato) | |
| Nome attuale | Santa Chiara | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Chiesa di santa Chiara | |
| Cronologia | 1693: realizzazione del portale della chiesa. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | La chiesa è quel che resta del complesso conventuale originario delle clarisse in città e sorge a ridosso del centro storico lungo la Strada del Cambio (attuale corso Cavour) attaccata ai resti di una domus ospitaliera e nelle adiacenze del complesso religioso di S. Lucia. La chiesa del convento delle clarisse presenta in facciata lo stemma francescano sul bel portale barocco, che rappresenta l'elemento caratterizzante della semplice architettura con il prospetto con conci sbozzati. L'ingresso, con gli stipiti con un gonfio toro, è arricchito dalla presenza di teste d'angelo con festoni e dello stemma. | |
| Iscrizioni | Sull'architrave del portale: "A.D: MDC/XCIII". | |
| Stemmi o emblemi araldici | Stemma sul portale (1693) con simbolo francescano e di una famiglia nobile | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Il complesso conventuale di Santa Chiara, dell'ordine delle clarisse, risale al sec. XV ma oggi appare completamente trasformato. Resta la chiesa, sorta in prossimità di una domus ospitaliera medievale, databile, per il suo prospetto con il portale barocco (1693), al sec. XVII. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, “Per Barletta. Passeggiata storico-artistica”, Rassegna Pugliese i Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 349-350.
Fiorella 1996: Danila Fiorella, I due monasteri di S. Chiara di Barletta tra Medioevo ed età moderna, in Chiara d’Assisi e il movimento clariano in Puglia, Atti del convegno di studi per l’VIII centenario della nascita di S. Chiara d’Assisi organizzato dal Centro di studi francescani della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Puglia (Bari-Santa Fara, 22-24 settembre 1994), a cura di P. Corsi e F. L. Maggiore, Bari 1996, 153-166. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Antonio Milone | |
| Data di compilazione | 02/02/2014 15:07:11 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:28:17 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/665 |
| Oggetto | Barletta, Santa Maria di Nazareth | |
|---|---|---|
| Tipologia | chiesa | |
| Nome attuale | Santa Maria di Nazareth | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | San Bartolomeo, Concezione di Maria, Santa Maria di Nazareth | |
| Cronologia | 1337: la chiesa, intitolata a San Bartolomeo, viene fondata da Giulia Acconzajoco. 1528: dopo la distruzione dei borghi esterni alla cinta muraria, l'arcivescovo di Nazareth perde la sua chiesa. 1544: Geronimo De Caro, arcivescovo di Nazareth, prende accordi per la concessione della chiesa di San Bartolomeo e di un attiguo palazzo, appartenente ai Santacroce, per installarvi la sua sede episcopale. 1566: soltanto in questo anno l'arcivescovo di Nazareth, Bernardino Figueroa, riesce a ottenere il possesso ufficiale della chiesa. 1571: Bernardino Figueroa riedifica la chiesa e la consacra alla Concezione di Maria. 1818: soppressione dell'arcivescovado di Nazareth. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | All'interno della chiesa erano una sepoltura (datata 1540) e un altare della famiglia Affaitati, dedicato nel 1583 e restaurato nel 1786; la famiglia avrebbe in seguito acquistato come propria residenza il palazzo Samuelli (poi Affaitati), esattamente di fronte alla chiesa. | |
| Descrizione | Interno a navata unica conclusa da abside. Copertura in legno. | |
| Iscrizioni | Iscrizione presso la porta della sagrestia (da Vista 1900-1904, II, 103): "BERARDINUS FIGUEROA ARCHIEPISCOPUS NAZARENUS / HANC ECCLESIAM AEDIFICARI FECIT A FUNDAMENTIS / AD GLORIAM DEI ET GLORIOSISSIMAE MARIAE / ANNO DOMINI MDLXXI". Sul retro, al di sopra di una porta: "D.O.M. / ORATORIUM NAZARENUM / DEIPARAE NAZARENAE VIRGINI DICATUM / A VERBO NAZARETH INCARNATO / MDCCXXXVI". | |
| Stemmi o emblemi araldici | Stemma in facciata, al di sopra del portale. | |
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | La chiesa e l'annesso palazzo erano la sede dell'arcivescovo di Nazareth, trasferitosi a Barletta dopo la perdita della Terra Santa, una prima volta dal 1187 al 1229, poi definitivamente, dopo vari spostamenti, nel 1310. Nel 1449, su pressione del re Alfonso d'Aragona, papa Callisto III accorda l'arcivescovado di Nazareth insieme con quello di Canne al frate osservante Giacomo Origlia. Il 5 febbraio 1459, il giorno successivo alla sua stessa incoronazione in Barletta, re Ferrante concede all'arcivescovo di Nazareth una fiera sotto il titolo dell'Annunziata, per la durata di nove giorni dal 22 al 30 marzo. Lo stesso sovrano nel 1461 accorda all'arcivescovo 200 carri di sale annui dalle saline di Barletta. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), II, 72-76. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, II, 90-113. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 09/01/2014 12:34:08 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:30:38 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/635 |
| Oggetto | Barletta, Santo Sepolcro | |
|---|---|---|
| Tipologia | chiesa | |
| Nome attuale | Santo Sepolcro | |
| Immagine |  | |
| Nomi antichi | Ecclesiam Sancti Sepulcri | |
| Cronologia | 1144: la "Ecclesiam Sancti Sepulcri in Barleto" è citata fra le possessioni del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Loffredo 1893, II, doc.VII, 269-272). 1160: scrittura di composizione fra Azzone, priore della cheisa barlettana, e l'abate del monastero di San Michele a Montescaglioso (Minieri Riccio 1882, doc. X, 14-15; Loffredo 1893, II, doc. VII, 273-274). 1182: papa Lucio III conferma al Santo Sepolcro di Gerusalemme il possesso della omonima chiesa di Barletta (Loffredo 1893, II, doc. IX, 275-279). 1261: papa Urbano IV ribadisce la dipendeza diretta della chiesa del Santo Sepolcro da quella di Gerusalemme, sottraendola alla giurisdizione del vescovo di Trani. 1291: dopo la presa di Tolemaide, i canonici del Santo Sepolcro di Gerusalemme si rifugiano nella chiesa di Barletta. 1312: re Roberto d'Angiò prende la chiesa sotto la propria protezione (Schulz 1860, I, 139, nota 2). 1489: soppresso da papa Innocenzo VIII l'istituto dei Canonici del Santo Sepolcro, la chiesa passa al clero secolare. 1556: la chiesa passa all'ordine dei Cavalieri di San Giovanni. 1770: viene abbattuto il portico e costruita la facciata attuale. 1885: abbattimento del campanile e trasferimento dell'orologio in una nuova torretta costruita sopra l'ex Seggio del Popolo. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | La chiesa era preceduta da un portico di cui resta soltanto una delle due arcate laterali e le porzioni inferiori dei pilastri. Il campanile sorgeva sopra lo spigolo sinistro della facciata, ma anche di esso sussistono adesso soltanto le porzioni inferiori. Il fianco sinistro è articolato da una successione di arcate cieche su lesene, mentre sul retro sporgono le tre absidi semicircolari. L'interno ha un impianto a tre navate suddivise da pilastri polistili coperte da volte a crociera; sopra il presbiterio è una cupola ottagonale poggiata su trombe sorrette da piccole colonnine incassate. In controfacciata è una tribuna, dal cui centro sporge un piccolo pulpito semicircolare poggiato su un sostegno a cono rovesciato. Accanto alla chiesa sorgeva, fino alla prima metà del XX secolo il seggio del Popolo, mentre sopra la sagrestia aveva sede l'archivio della città di Barletta. | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | All'ingresso del Seggio del Popolo era la statua detta Colosso, attualmente all'esterno del fianco destro della chiesa. | |
| Opere d'arte medievali e moderne | Affreschi medievali (Pace 2005). Numerosi oggetti appartenenti al Tesoro e portati dalla Terra Santa nel 1291. | |
| Storia e trasformazioni | La chiesa, dipendente direttamente dalla omonima commenda di Gerusalemme, era probabilmente dotata anche di un ospizio destinato a ospitare i pellegrini diretti verso la Terra Santa. Era stata costruita fuori città, ma dopo l'ampliamento delel mura del 1162, risulta inclusa nella nuova cinta muraria. | |
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Ambrosi 1993: Angelo Ambrosi, Architettura dei Crociati in puglia. Il Santo Sepolcro di Barletta, Bari 1993.
Bertaux 1904: Emile Bertaux, L'art dans l'Italie méridionale, de la fin de l'Empire romain à la Conquête de Charles d'Anjou, Paris 1904, 690-694.
Caraballese 1898: Francesco Carabellese, "L'Ordine di Gerusalemme in Puglia sotto i re normanni e svevi", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 15, 1898, 2-6.
De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350.
Enlart 1894: Camille Enlart, Origines françaises de l'architecture gothique en Italie, Paris 1894, 163-176, figg. 59-67
Fiorella 2005: Danila Fiorella, “La presenza degli Ordini monastico-cavallereschi a Barletta”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 409-434.
Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).
Minieri Riccio 1882: Camillo Minieri Riccio, Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli, supplemento 1, Napoli 1882, 14-15.
Pace 2005: Valentino Pace, “Echi della Terrasanta: Barletta e l’Oriente crociato”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 393-408.
Pedico 1949: Oronzo Pedico, La chiesa del Santo Sepolcro di Barletta, Barletta 1949, 11-13.
Prologo 1885: Arcangelo Prologo, “Una bolla di papa Lucio III che da taluni erroneamente si dice conceduta in favore dei Templari”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 2, 1885, 163-168.
Russo 1993: Renato Russo, La Basilica del Santo Sepolcro di Barletta, la storia, l'architettura, Barletta 1993.
Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 139-140.
Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, II, 3-61. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 24/09/2013 18:49:22 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:32:32 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/500 |
| Oggetto | Barletta, seggio dei nobili | |
|---|---|---|
| Tipologia | edificio pubblico: sedile | |
| Nome attuale | (distrutto) | |
| Immagine |   | |
| Nomi antichi | Sedile di Gesù, Sedile della Madonna Greca | |
| Cronologia | XV secolo: costruzione. 1938: sul sito del vecchio palazzo della Marra, ospitante il seggio, viene costruita la nuova sede della Banca d'Italia. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | famiglia della Marra | |
| Descrizione | Il seggio dei nobili, a differenza di quello del Popolo, non era un edificio autonomo, ma un loggiato al piano terreno del palazzo della Marra, ad angolo fra l'attuale via Garibaldi e la vecchia via del Cambio, oggi Cavour (Loffredo 1893, I, 396, 406). A differenza di altri sedili nobili del regno di Napoli, quello di Barletta era un "sedile aperto" (Loffredo 1893, I, 218). | |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Elementi antichi di reimpiego | ||
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | ||
| Bibliografia | Beltrani 1885: Giovanni Beltrani, "Un saggio di studio sugli antichi seggi di Barletta", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed arti, II, 1885, 104-108. De Leone 1888: Filippo De Leone, “Un documento del patriziato di Barletta”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 30-32. Lenzo 2014: Fulvio Lenzo, Memoria e identità civica. L'architettura dei seggi nel Regno di Napoli (XIII-XVIII secolo), Roma 2014.
Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).
Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 45. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 11/11/2013 08:54:07 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:37:29 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/602 |
| Oggetto | Barletta, seggio del popolo | |
|---|---|---|
| Tipologia | edificio pubblico: sedile | |
| Nome attuale | (distrutto) | |
| Immagine |   | |
| Nomi antichi | ||
| Cronologia | 1442: Alfonso il Magnanimo concede che si faccia il mercato franco del lunedì "a lo loco di Araco". Non è tuttavia chiaro se tale collocazione, chiaramente connessa con la statua del Colosso, fosse nell'area poi occupata dal seggio, oppure nella zona del porto, dove la statua è documentata dal 1309. 1491: data riferita tradizionalmente alla ricostruzione del seggio. Le evidenze documentarie non accennano all'edificio, tuttavia la datazione appare congruente con il restauro della statua bronzea del Colosso, proprio nel 1491, e con la concessione da parte del sovrano dei nuovi statuti che riservavano ai rappresentanti del popolo i due terzi dei seggi del consiglio cittadino (Faraglia 1883, 155). 1790: interventi di ridecorazione (Vista 1900-1904, I, 46). 1799: l'edificio viene adibito a corpo di guardia (Loffredo 1893, II, 148; Vista 1900, 46). 1855: al di sopra dell'edificio viene costruita una torretta per collocarvi l'antico orologio che sino a quell'epoca era sul campanile della chiesa. 1870 ca.: trasformato in ufficio postale, poi in Gabinetto di lettura e quindi in libreria. 1925: l'edificio viene abbattuto. | |
| Autore | ||
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Descrizione | L'edificio aveva forma di padiglione addossato al fianco della chiesa del Santo Sepolcro. Chiuso sui lati, in facciata si apriva con una grande arcata a sesto acuto, poi tamponata, inquadrata fra due paraste. Al di sopra della copertura in epoca successiva era stata costruita una torretta con orologio. Secondo Loffredo 1893, I, 406, il seggio del popolo di Barletta era stato costruito contemporaneamente al seggio dei nobili. | |
| Iscrizioni | Sotto uno degli stemmi della città (cfr. Stemmi o emblemi araldici), era la data MDVIIII (Vista 1900-1904, I, 45). | |
| Stemmi o emblemi araldici | Due stemmi in marmo inseriti ai lati della grande arcata in facciata sono visibili nelle fotografie d'epoca: quello di destra è chiaramente uno stemma aragonese, quello di sinistra mostra uno scudo sormontato da cimiero, di cui tuttavia non sono leggibili le imprese. Un altro stemma era murato sul fianco sinistro del seggio. Secondo Vista (1900-1904, I, 45), uno degli stemmi era quello della dinastia aragonese, due rappresentavano le armi della città di Barletta, e il quarto quelle di Carlo V. | |
| Elementi antichi di reimpiego | "Colosso", statua bronzea ritenuta ritratto stante dell'imperatore Eraclio. | |
| Opere d'arte medievali e moderne | ||
| Storia e trasformazioni | Risale a un intervento di fine XIX secolo la costruzione della torretta con l'orologio e la trasformazione in libreria con la chiusura dell'arcata in facciata. | |
| Note | Appare interessante che il restauro del colosso e verosimilmente la costruzione del seggio siano contemporanei ai nuovi statuti concessi alla città di Barletta da Ferrante nel 1491, in base ai quali il popolo acquisiva una preminenza netta rispetto ai nobili (due terzi contro un terzo) nel consiglio cittadino. Il Seggio dei nobili era in un portico al piano terreno dello scomparso Palazzo della Marra. Rimane da verificare l'attendibilità della notizia che il colosso si trovasse già in città nel 1442: Testini, e dopo di lui tutta la letteratura recente, si rifanno a Vista 1900-1904, I, 41-42, il quale, tuttavia, precisa di avere letto la notizia soltanto in un trasunto notarile e di non aver potuto verificarla sulla pergamena (concessa da Alfonso il Magnanimo il 13 dicembre 1442), poiché ai suoi tempi la pergamena era a Napoli. La pergamena è trasunta in Repertorio pergamene Barletta (1904, doc. CXXXIII, 137-138), dove si dice che la città ottiene la concessione del mercato franco del lunedì nel luogo detto "Arachi". Nessuna indicazione si ha sulla collocazione topografica di questo luogo, che potrebbe riferirsi anche alla vecchia collocazione della statua presso la dogana del molo. | |
| Fonti iconografiche | Dell'edificio del seggio del popolo di Barletta esistono diverse incisioni nonché fotografie anteriori al suo abbattimento. | |
| Piante e rilievi | ||
| Fonti/Documenti | La mutilazione del Colosso nel 1309 per ordine di Carlo II d'Angiò è attestata dal documento già in Archivio di Stato di Napoli, Registri Angioini, Registro 185, anno 1309 B, ff. 249 recto-verso (da Loffredo 1893, I, 72, nota 2): “Scriptum est Secretis Magistris portulanis et procuratoribus ac magistris salis Apuliae etc. Ad religiosas personas divinis deputatas obsequiis nostrum benigne vertentes intuitum et specialem gerentes affectum. Cum ipsis in earum supplicationibus agimus gratiose, igitur fidelitati vestrae precipimus quatenus religiosis viris fratribus predicatoribus in Manfredonia morantibus seu ipsorum nunciis ymaginem de metallo existentem in dohana Baroli de qua dictis fratribus in subsidium campanae et loci quem construunt duximus providendum auctoritate presentium assignari faciatis instanter et recipi exinde ydoneam apodixam. Data Baroli per Magistros Rationales Die viiii Junii vii Indietionis”. Il restauro del Colosso nel 1491 è ricordato in una composizione poetica, probabilmente coeva, tramandata da Grimaldi 1607, 129: “Devicto Persarum Rege Heraclius offert Praeclarae Christi pristina dona Cruci. Quam supplex Calvariae adorat monte repostam, Cum Christi populo se comitante simul. Septeno hinc anno in Cosdram, Persasque prophanos Confisus Christo martia bella gerit. Anno sexcenteno a partu Virginis almae Constantini Urbi hic imperat egregie. Principis excelsi talem formavit ideam Pulyphobus Graecus doctus in arte faber. Post Veneti acres Constantini hanc Urbe repertam In patriam laeti ducere nave parant. Littoribus Baroli appulsa est tunc naufraga puppis; Turbine ventorum strata jacet statua. Strata jacet campo statua haec jam tempore longo Virginis astriferae: quae caret hercle manu. Albanus Fabius, qui rite peritus in arte, Crura, manusque, pedes aptat utrinque faber. Ipsa Crucem gestat dextraque, pilumque sinistra: Tutor namque Crucis, sicque Monarcha fuit. Urbs Barolita potens, Cannarum maxima proles Laude hac perpetua famigeravit opus”. | |
| Bibliografia | Bartsch 2003: Tatiana Bartsch, “Francisco de Holanda und der Koloss von Barletta. Zum Antikenstudium nicht-italienische Kuenstler der Renaissance fuori Roma”, Pegasus. Berliner Beitraege zum Nachleben der Antike, 4, 2003, 115-158.
Beltrani 1885: Giovanni Beltrani, "Un saggio di studio sugli antichi seggi di Barletta", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed arti, 2, 1885, 104-108.
Faraglia 1883: Nunzio Federico Faraglia, Il comune nell’Italia meridionale dalla conquista normanna all’invasione napoleonica, Napoli 1883.
Grimaldi 1607: Giovan Paolo Grimaldi, Vita di S. Ruggiero vescovo et confessore, patrono di Barletta [...], Napoli, nella Stamperia di Tarquinio Longo, 1607.
Lenzo 2014: Fulvio Lenzo, Memoria e identità civica. L'architettura dei seggi nel Regno di Napoli (XIII-XVIII secolo), Roma 2014. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).
Marulli 1816: Troiano Marulli, Discorso storico critico sopra il Colosso della Città di Barletta del conte Troiano Marulli, Napoli, nella Stamperia di Angelo Coda, 1816.
Repertorio pergamene Barletta 1904: Repertorio delle Pergamene dell’Università o Comune di Barletta (1234-1658), Napoli 1904. Schulz 1860: Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 143-149.
Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842.
Testini 1973: Pasquale Testini, “La statua di bronzo o Colosso di Barletta”, Vetera Christianorum, 10, 1973, 127-152.
Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 35-47. | |
| Link esterni | Una prima e una seconda fotografia che documentano il seggio con le protezioni belliche del 1916 sono visibili on line. | |
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 24/09/2013 16:54:00 | |
| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:38:53 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/499 |
| Oggetto | Barletta, iscrizione dell'archivio (1567) | |
|---|---|---|
| Supporto | ||
| Cronologia | 1567 | |
| Immagine |  | |
| Prima attestazione | Iscrizione apposta all'esterno della sede storica dell'archivio della città di Barletta. | |
| Trascrizione |
FIDELE BAROLVM PRO CONSERVATIONE REGIORVM / PRIVILEGIORVM MAGNIFICO HYERONIMO PONTELLVSIO / SINDICO AN(N) D(OMI)NI MDLXVII REGNANTE INVITTI/SSIMO D(OMI)NO N(OST)RO D(OMI)NO PHILIPPO DE AVSTRIA REGE / YSPANIE VTRIVSQ(VE) SICILIE HYERVSALEM. | |
| Famiglie e persone |
Girolamo Pontellusio Filippo II | |
| Note |
Il locale dell'Archivio cittadino, soprastante la sacrestia della chiesa del Santo Sepolcro, fu costruito a spese dell'Università. Precedentemente, nella stessa chiesa, forse nella sacrestia, era conservata la cassa contenente, secondo le disposizioni di re Ferrante del 1491, il sigillo, il libro del Cancellierato, le bussole e i sacchetti per le elezioni dei priori, altre scritture e libri prodotti dagli ufficiali cittadini. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), II, 363-380, 415-435.
Trinchera 1866-1874: Francesco Trinchera, Codice Aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del Reame e le relazioni all'estero, 3 voll., Napoli 1866-1874, III, 113-131. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo, Veronica Mele | |
| Data di compilazione | 12/12/2013 10:45:05 | |
| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:43:10 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Iscrizione/50 |
| Oggetto | Barletta, iscrizione della peste del 1498 | |
|---|---|---|
| Supporto | marmo | |
| Cronologia | 1498 | |
| Immagine |  | |
| Prima attestazione | La lapide è murata nel campanile della chiesa di San Cataldo. | |
| Trascrizione | AD 1498 PESTE IN/FESTANTE PIA RES PUB. BAROLITANA / INSTAVRAVIT | |
| Famiglie e persone | ||
| Note | L'iscrizione è in lettere tracciata con lettere inscrivibili entro il quadrato ed è sormontato dallo stemma coronato della città di Barletta racchiuso entro una cronice rettangolare. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, V, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), I, p. 392, nota 38. Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 10:06:51 | |
| Data ultima revisione | 23/02/2017 00:39:38 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Iscrizione/42 |
| Oggetto | Barletta, iscrizione di Carlo V | |
|---|---|---|
| Supporto | Pietra calcarea | |
| Cronologia | 1537 | |
| Immagine |  | |
| Prima attestazione | L'iscrizione è murata nel castello di Barletta. | |
| Trascrizione | CAROLVS QVINT/VS REX ISPANIAE / IMPERATOR RO/MANORVM SEM/PER AVGVSTVS / MCCCCCXXXVII. | |
| Famiglie e persone | Carlo V | |
| Note | L'iscrizione è intagliata all'interno di una tabula ansata con campo epigrafico nettamente delineato. L'intaglio delle lettere non è molto raffinato (soprattutto la lettera "S") e si nota una inversione nella lettera "N" della parola "ROMANORVM". Al di sopra della lastra è murato uno stemma dell'imperatore Carlo V. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. | |
| Link esterni | ||
| Schedatore | Fulvio Lenzo | |
| Data di compilazione | 02/12/2013 09:02:14 | |
| Data ultima revisione | 23/02/2017 00:50:18 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Iscrizione/40 |
| Oggetto | Barletta, Cattedrale, Cristo alla colonna | |
|---|---|---|
| Collocazione originaria | ||
| Materiale | olio su tavola | |
| Dimensioni | ||
| Cronologia | 1434 | |
| Autore | Giovanni di Francia (attr.) | |
| Descrizione | L’opera, datata 1434, è conservata nella prima cappella sinistra della Cattedrale di Barletta, e raffigura Cristo alla colonna. Ai lati della figura centrale si dispongono quattro figure di angeli in preghiera. | |
| Immagine |   | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | L’autore è stato identificato da Michele D’Elia (1964, 54) in Giovanni di Francia, pittore di origini francesi presto stabilitosi a Venezia, dov’è attestato a partire dal 1405. La Madonna col Bambino in trono (1429) del Museo di Palazzo Venezia a Roma, nei fatti unica opera certa di Giovanni perché firmata, costituisce il termine di paragone per la ricostruzione dell’attività dell’artista transalpino. Questi dovette formarsi a Venezia sugli esempi di Nicolò di Pietro, pittore molto attivo in laguna dal 1394 agli anni venti del XV secolo, e a sua volta molto vicino a Gentile da Fabriano. Di stanza a Venezia, Giovanni di Francia fu molto apprezzato in aree periferiche, non solo del Veneto e del Friuli, ma anche del marchigiano e della Puglia. Molte furono le opere inviate in altrettante località pugliesi, tra le quali doveva spiccare, perché firmata e datata al 1432, una Crocefissione tra la Vergine e San Giovanni, oggi perduta, ma un tempo conservata nella cripta del Duomo di Trani. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Claut 1999: Sergio Claut, "Per Giovanni di Francia", Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, 70, 1999, 214-215.
D’Elia 1954: Michele D’Elia, Mostra dell’arte in Puglia dal tardo antico al Rococò, Bari 1964, 54.
Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 114. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 06/05/2014 14:48:24 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 10:55:45 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/456 |
| Oggetto | Barletta, Cattedrale, frammento marmoreo | |
|---|---|---|
| Materiale | marmo con tracce di policromia | |
| Dimensioni | ||
| Cronologia | terzo quarto del XV secolo | |
| Autore | ||
| Descrizione | Il marmo, oggi utilizzato come paliotto di un altare all’interno della Cattedrale di Barletta, è decorato da due angeli parzialmente inginocchiati ai lati di una figura maschile centrale dal cui torace fuoriescono due grandi cornucopie traboccanti di motivi vegetali stilizzati. | |
| Immagine |   | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | L’inusuale collocazione del frammento, posto al di sotto di un altare, induce a pensare che si tratti di un pezzo erratico forse proveniente da un sepolcro oggi non più esistente e che sia dunque frutto di un riassemblaggio operato in epoca imprecisata. L’analisi stilistica e tipologica orienta verso una datazione dell'opera al terzo quarto del Quattrocento. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | ||
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 06/05/2014 20:21:09 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 14:31:05 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/458 |
| Oggetto | Barletta, Cattedrale, tabernacolo eucaristico | |
|---|---|---|
| Materiale | marmo | |
| Dimensioni | ||
| Cronologia | metÓ del XVI secolo | |
| Autore | ||
| Descrizione | L’opera, custodita nella Cattedrale di Barletta, è parte di uno smembrato tabernacolo eucaristico della metà del Cinquecento. Essa è costituita da un frontale architettonico proiettato nello spazio grazie all’espediente del pavimento scorciato, e da un fastigio lunettato che accoglie al centro la colomba dello Spirito Santo attorniata da una ghiera di testine di cherubini. In basso la figura del Bambino in fasce è affiancata da due coppie di angeli adoranti che sbucano dalle porticine laterali profondamente scolpite e rappresentate in scorcio. Ci si trova dunque di fronte ad un’edicola eucaristica a parete, forse dismessa a seguito delle disposizioni imposte dal Concilio di Trento in materia di culto sacramentale. L’autore dovette verosimilmente essere un ignoto scalpellino locale operoso alla metà del XVI secolo. | |
| Immagine |   | |
| Committente | Monaco Elefante | |
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | "MONACUS ELEFANTE FECIT". | |
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | Come attestato dall’iscrizione, l’opera è stata commissionata dal nobile barlettano Monaco Elefante, nell’ambito di un più ampio impegno della famiglia Elefante a favore dell’ampliamento dell’area presbiteriale della Cattedrale alla metà del Cinquecento. A Palmerio e a Monaco, esponenti della nota famiglia il cui palazzo s’ergeva sull’attuale via Cavour (oggi Palazzo De Leone Pandolfelli), spettano in particolare il finanziamento della “facciata laterale a settentrione di là del campanile”, unitamente al portale laterale nord che reca le armi degli Elefante (Loffredo, II, 91; Vista, 62-63, 72) nonché il completamento dei lavori del coro a deambulatorio retrostante l’altare maggiore e nel quale si aprono cinque cappelle radiali. Di queste ultime, Palmerio ed Elefante se ne assicurarono ben due: la prima, quella centrale, nella quale è custodita la tavola con la Madonna col bambino e il Redentore, e la seconda, intitolata al Santissimo Sacramento, e alla cui decorazione dovette provvedere Monaco. L’edicola eucaristica si pone dunque come parte di un più articolato e complesso arredo scultoreo, oggi non più esistente, della cappella atta a custodire il Santissimo Sacramento. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta, Trani 1893, II, 91.
Vista 1900: Francesco Saverio Vista, Note storiche sulla città di Barletta, Barletta 1900, 62-63. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 06/05/2014 13:02:00 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 14:40:08 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/455 |
| Oggetto | Barletta, San Giacomo, monumento funebre | |
|---|---|---|
| Materiale | marmo | |
| Dimensioni | ||
| Cronologia | prima metÓ del XIV secolo | |
| Autore | ||
| Descrizione | La tomba, collocata nel vestibolo della chiesa di San Giacomo, è costituita da un basamento su cui s’innalzano due colonne a loro volta sostenenti un sarcofago la cui fronte reca scolpita la figura intera di un vescovo con mitra e pastorale. Il bordo superiore del sarcofago reca incisa un’iscrizione non più leggibile perché corrosa. La figura del defunto è caratterizzata da tratti netti e taglienti, essenziali nell’estrema linearità, e che conferiscono all’immagine una viva immediatezza espressiva. La decorazione della cornice del sarcofago, non priva di una certa ricercatezza ed eleganza formale, induce a pensare che l’autore possa identificarsi con un non modesto scalpellino attivo in qualche bottega locale entro la prima metà del XIV secolo. Ai lati del basamento sono scolpiti due scudi che, a detta del Vista (1900, 76), sarebbero stati scalpellati e resi dunque illeggibili. | |
| Immagine |   | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | Secondo Vista (1900, 76-77), la tomba commemorerebbe ben tre vescovi barlettani: due vissuti nel corso del XII secolo, vale a dire Guglielmo e Pasquale, ed un terzo, Riccardo Galimberti, defunto nel 1439. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Vista 1900: Francesco Saverio Vista, Note storiche sulla città di Barletta, Barletta 1900, 76-77. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 06/05/2014 17:46:55 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 14:44:07 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/457 |
| Oggetto | Barletta, Sant'Andrea, Madonna col Bambino in trono | |
|---|---|---|
| Materiale | olio su tavola | |
| Dimensioni | cm 183 x 75 | |
| Cronologia | 1483 | |
| Autore | Alvise Vivarini | |
| Descrizione | La tavola, custodita nella chiesa di Sant'Andrea, raffigura la Madonna col Bambino in trono. Essa è firmata e datata sul cartellino da Alvise Vivarini, che la eseguì nel 1483. Una più tarda, e grandiosa, macchina lignea dorata inquadra l’opera, che in origine doveva essere affiancata da tavole laterali oggi perdute. Non si ha alcuna traccia della committenza e della sua originaria collocazione. Compiuta nel periodo della maturità dell’artista, anche quest’opera d’”importazione” testimonia efficacemente la comprensione e la profonda assimilazione, da parte di Alvise, della pittura “nuova” che Antonello da Messina aveva portato a Venezia negli anni settanta del Quattrocento. In particolare, l’uso della luce tersa e fredda che colpisce i due protagonisti, dai volti simili a solidi geometrici, e la tendenza ad una salda costruzione degli spazi denunciano, in questa fase, la vicinanza del Vivarini al messinese. | |
| Immagine |   | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone |
| |
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | Al 1484, e dunque a pochissima distanza dalla tavola di Barletta, risale una Madonna col Bambino in trono tra i Santi Sebastiano e Antonio da Padova e il committente Niccolò Trevisan, realizzata per la Cattedrale di Ceneda (TV) da Jacopo da Valenza, allievo di Alvise. Tale raffigurazione potrebbe forse suggerire l’aspetto originario dell’opera del Vivarini (Barbone Pugliese 2012, 20). | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Barbone Pugliese 2012: Nuccia Barbone Pugliese, Pittori veneziani in Puglia e fuoriusciti napoletani in Francia, in Tiziano, Bordon e gli Acquaviva d’Aragona, cat. mostra (Bitonto, 15 dicembre 2012-8 aprile 2013), Foggia 2012, 20.
Frizzoni 1914: Gustavo Frizzoni, "Opere di pittura Venete lungo la costa meridionale dell’Adriatico", Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 8, 1914, 23-40.
Gelao 2011: Clara Gelao, "Qualche osservazione sulla Madonna con Bambino di Alvise Vivarini nella chiesa di Sant’Andrea a Barletta", in Scritti in onore di Marina Causa Picone, Napoli 2011, 143-155.
Gelao 2016: Clara Gelao, “La ‘Madonna con Bambino in trono’ di Alvise Vivarini a Barletta nel contesto degli arrivi di opere dei Vivarini in Puglia”, in Giuseppe Riefolo, Filippo Maria Ferro, Il caso Vivarini a Barletta. Dalla Madonna in trono (1483) nella chiesa di Sant’Andrea ai percorsi di Alvise Vivarini sulla costa adriatica, Barletta 2016, 29-55. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 01/05/2014 18:57:14 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 14:47:05 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/453 |
| Oggetto | Barletta, Sant'Andrea, statua del Battista | |
|---|---|---|
| Materiale | marmo | |
| Dimensioni | 150 cm | |
| Cronologia | 1565-70 | |
| Autore | Giovandomenico d'Auria (attr.) | |
| Descrizione | La statua si trova nella chiesa di Sant'Andrea a Barletta. | |
| Immagine |  | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | Il San Giovanni Battista è stato presentato da Riccardo Naldi quale prodotto di schietta provenienza napoletana ed in questo senso è stato ricondotto all’ambito della cosiddetta ‘società Caccavello-D’Auria’, vale a dire a quella vera e propria organizzazione e suddivisione delle commesse marmoree messa in opera alla metà del Cinquecento dagli scultori Annibale Caccavello e Giovan Domenico d’Auria dopo la morte del maestro Giovanni Meriliano da Nola. Per lo studioso, l’autore del marmo dovette avere “una conoscenza vasta dei moduli compositivi elaborati da Giovanni da Nola fin quasi alla metà del secolo e li ripropone con un’intensità naturalistica che tiene comunque conto dello stile maturo del Santacroce”. Utili confronti, secondo Naldi, possono istituirsi fra questo Battista e alcuni degli Apostoli rappresentati nello scomparto inferiore dell’ancona monumentale raffigurante l’Assunzione della Vergine realizzata fra il 1557 e il 1566 dal Caccavello e dal D’Auria nella Cappella Di Somma all'interno della chiesa agostiniana di San Giovanni a Carbonara. Naldi non ha avanzato un’attribuzione precisa, e si è limitato ad avvicinare il Battista di Barletta alla scultura di uguale soggetto conservata a Pizzo Calabro, il cui impianto compositivo è a suo parere caratterizzato da “una maggiore scioltezza, basata su di un dinamismo dei contrapposti più agili e scattanti che appaiono derivazione letterale” da un terzo San Giovanni Battista custodito a San Giovanni a Carbonara. Quest’ultima statua viene considerata da Naldi “opera dalle elevate qualità d’impostazione che la legano agli esiti estremi di Giovanni da Nola”. L’analisi del punto di stile, unita a confronti con opere certe, induce ad assegnare il precursore di Barletta alla tarda attività di Giovan Domenico d’Auria, autore del coevo San Rocco per la chiesa del Santo a Catanzaro. Il tipo umano espresso dallo scultore in queste due figure è identico, così come è simile il trattamento delle vesti e dei volti, la resa della folta capigliatura, costituita da spessi e morbidi ciuffi tipici delle figure di Giovan Domenico. Un ulteriore dettaglio degno di nota, chiaramente riscontrabile nelle sculture monumentali dauriane, è il gonfiarsi delle vene delle mani e dei piedi, come si rileva, oltre che nel San Rocco di Catanzaro, nel San Giovanni Battista del Museo Campano di Capua. | |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Coniglio 2007: Paola Coniglio, Rappresentazioni del Battista nella scultura monumentale napoletana del Cinquecento, tesi di specializzazione in storia dell’arte, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, anno accademico 2006/2007, 96-100.
Coniglio 2010: Paola Coniglio, “Giovan Domenico d’Auria, Annibale Caccavello e l’Apostolato’ dell’Annunziata di Napoli”, Prospettiva, 139-140, luglio-ottobre 2010, 137-150.
Naldi 2004: Riccardo Naldi, “Scultura del Cinquecento in Puglia: arrivi da Napoli”, in Scultura del Rinascimento in Puglia, Atti del Convegno Internazionale (Bitonto, 21-22 marzo 2001), Bari 2004, 161-186. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 04/02/2014 18:08:38 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 14:55:15 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/448 |
| Oggetto | Barletta, Sant'Andrea, tavola di Sant'Antonio da Padova | |
|---|---|---|
| Materiale | olio su tavola | |
| Dimensioni | cm 167 x 77 | |
| Cronologia | anni ottanta del Quattrocento | |
| Autore | Alvise Vivarini (attr.) | |
| Descrizione | La tavola, raffigurante Sant’Antonio da Padova, è custodita nella seconda cappella sinistra della chiesa di Sant’Andrea. Il Santo si erge maestoso, con i gigli nella destra e un libro nella sinistra, su un ameno paesaggio naturale interrotto soltanto, sulla sinistra, da un grande edificio. | |
| Immagine |   | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | ||
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | Dopo una prima, e generica attribuzione di Gustavo Frizzoni (1914, 25) all’ambito dei Vivarini, dalla cui attiva bottega tante opere giunsero in Puglia nel corso dell’ultimo quarto del XVI secolo, Nuccia Barbone Pugliese (2012) ha circoscritto il campo ad Alvise, autore della Madonna col Bambino in trono conservata all’interno della medesima fabbrica.
| |
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Barbone Pugliese 2012: Nuccia Barbone Pugliese, Pittori veneziani in Puglia e fuoriusciti napoletani in Francia, in Tiziano, Bordon e gli Acquaviva d’Aragona, cat. mostra (Bitonto, 15 dicembre 2012-8 aprile 2013), Foggia 2012, 20.
Frizzoni 1914: Gustavo Frizzoni, "Opere di pittura Venete lungo la costa meridionale dell’Adriatico", Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 8, 1914, 23-40.
Riefolo, Ferro 2016: Giuseppe Riefolo, Filippo Maria Ferro, Il caso Vivarini a Barletta. Dalla Madonna in trono (1483) nella chiesa di Sant’Andrea ai percorsi di Alvise Vivarini sulla costa adriatica, Barletta 2016. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Paola Coniglio | |
| Data di compilazione | 03/05/2014 19:15:48 | |
| Data ultima revisione | 12/02/2017 15:03:17 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/454 |
| Oggetto | Barletta, Santo Sepolcro, Madonna di Costantinopoli (dipinto) | |
|---|---|---|
| Collocazione originaria | ||
| Materiale | tempera su tavola a fondo oro | |
| Dimensioni | 132 x 90 cm | |
| Cronologia | Prima metÓ del XVI secolo | |
| Autore | Donato Bizamano | |
| Descrizione | La tavola raffigura la Madonna che abbraccia il Bambino su fondo oro e due angeli che sorreggono la corona. Attualmente è collocata nella basilica del Santo Sepolcro a Barletta; è noto che nella chiesa ci fosse, almeno all’inizio del Novecento, un altare dedicato alla Madonna di Costantinopoli sul quale Gelao (1988, 143) suggerisce fosse collocata la tavola.
| |
| Immagine |   | |
| Committente | ||
| Famiglie e persone | ||
| Iscrizioni | MHP ϴY. O AГ. M / O AГ. Г. | |
| Stemmi o emblemi araldici | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Fonti e documenti | ||
| Bibliografia | Calò 1968: M. S. Calò, «Opere di pittura del Cinquecento e del primo Seicento importate in Puglia», Lettere, 94-96, 1968, 20.
Calò 1969: M. S. Calò, Contributo alla storia dell’arte in Puglia. La pittura del Cinquecento e del primo Seicento in terra di Bari, Bari 1969, 22.
Cassandro 1957: M. Cassandro, Barletta nella storia e nell’arte, Barletta 1957, 293.
D’Elia, Belli 1969: M. D’Elia, P. Belli, Icone di Puglia, a cur di Pina Belli e Michele D’Elia, cat. Mostra, Bari, Pinacoteca Provinciale, 1969 (ciclostilato), pubblicato in Puglia e Basilicata tra Medioevo ed età moderna - Uomini spazio e territorio. Studi storici in onore di Cosimo D. Fonseca, a cura di Fernando Ladiana, Galatina 1988, 199-217, 212.
Gelao 1988: Clara Gelao, «Donato Bizamano. 51. Madonna con Bambino incoronata dagli angeli (Madonna di Costantinopoli)», in Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo al Settecento, a cura di Pina Belli D’Elia, cat. mostra (Bari, Pinacoteca provinciale), Milano 1988, 143-144.
Mostra dell’arte in Puglia 1964: Mostra dell’arte in Puglia dal tardo-antico al rococò, a cura di Michele D’Elia, cat. mostra (Bari, Pinacoteca provinciale), Roma 1964, 103.
Russo 1934: R. Russo, «La chiesa del Santo Sepolcro in Barletta», Crociata, 1934, 3-10, 10.
| |
| Allegati | ||
| Link esterni | https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1600039441 | |
| Schedatore | Stefania Castellana | |
| Data di compilazione | 13/12/2023 14:05:07 | |
| Data ultima revisione | 13/12/2023 14:05:07 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/709 |
| Oggetto | Barletta, Colosso | |
|---|---|---|
| Luogo di provenienza | ||
| Collocazione attuale | La statua, abbandonata per lungo tempo presso il porto, è stata poi collocata probabilmente sin dal 1491 all'ingresso del seggio del popolo; dopo questo edificio è stato abbattuto è rimasta sul luogo, all'esterno della chiesa del Santo Sepolcro. | |
| Prima attestazione | La statua è menzionata per la prima volta nel 1309 in un editto di Carlo d'Angiò (Napoli, Archivio di Stato, Regesto n. 185, anno 1309 B, c. 249 r, v; trascritto in Loffredo 1893, I, 72, nota 2). | |
| Materiale | Bronzo | |
| Dimensioni | h 5 ca. | |
| Stato di conservazione | Manca la parte sommitale della calotta cranica; le gambe, la mano sinistra, a partire da appena sopra il polso, una porzione del braccio destro, incluso il gomito (a partire da circa cm 17 oltre le pteryges), la mano destra e la croce sono di restauro e attribuiti tradizionalmente a Fabio Albano, che avrebbe realizzato le integrazioni nel 1491 (cfr. infra, Grimaldi 1607). | |
| Cronologia | metÓ del V secolo d.C. (Demougeot 1982); 455-475 (Leone I ?: Meischner 2001 con bibliografia) | |
| Descrizione | [SCHEDA IN COSTRUZIONE] | |
| Immagine |  | |
| Famiglie e persone | ||
| Collezioni di antichitÓ | ||
| Note | ||
| Fonti iconografiche | ||
| Rilievi | ||
| Fonti e documenti | Nel 1309 re Carlo II d'Angiò autorizza ad utilizzare il metallo della statua per fondere la campana grande della chiesa dei domenicani di Manfredonia (già in Archivio di Stato di Napoli, Registri Angioini, Registro 185, anno 1309 B, ff. 249 recto-verso; Loffredo 1893, I, 72, nota 2): “Scriptum est Secretis Magistris portulanis et procuratoribus ac magistris salis Apuliae etc. Ad religiosas personas divinis deputatas obsequiis nostrum benigne vertentes intuitum et specialem gerentes affectum. Cum ipsis in earum supplicationibus agimus gratiose, igitur fidelitati vestrae precipimus quatenus religiosis viris fratribus predicatoribus in Manfredonia morantibus seu ipsorum nunciis ymaginem de metallo existentem in dohana Baroli de qua dictis fratribus in subsidium campanae et loci quem construunt duximus providendum auctoritate presentium assignari faciatis instanter et recipi exinde ydoneam apodixam. Data Baroli per Magistros Rationales Die viiii Junii vii Indietionis”.
| |
| Bibliografia | Bartsch 2003: Tatiana Bartsch, "Francisco de Holanda und der Koloss von Barletta. Zum Antickenstudium nicht-italienische Kuenslter der Renaissance fuori Roma", Pegasus. Berliner Beitraege zum Nachleben der Antike, 4, 2003, 115-158.
Demougeot 1982: Émilienne Demougeot, "Le Colosse de Barletta", Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 94/2, , Rome 1982, 951-978.
De Tommasi 1982: Giambattista De Tommasi, "Il restauro dl Colosso Barletta", Vetera Christianorum 19, 1982, 131-155.
Grimaldi 1607: Giovan Paolo Grimaldi, Vita di S. Ruggiero vescovo et confessore, patrono di Barletta [...], Napoli, nella Stamperia di Tarquinio Longo, 1607.
Hornig 2008: Karin Hornig, "Der Koloss von Barletta. Odyssee einer konstantinischen Statue", Skyllis, 8, 2007/08, 100-123.
Jordan-Ruwe 1995: Martina Jordan-Ruwe, Das Säulenmonument: zur Geschichte der erhöhten Aufstellung antiker Porträtstatuen, Bonn 1995, 3, 142, 165, 191.
Kiilerich 2015: Bente Kiilerich, “The Barletta Colossos Revisited: the Methodological Challenges of an Enigmatic Statue”, Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia, 28, 2015, 55-72.
Koch 1912-1913: Herbert Koch, "Bronzestatue in Barletta", Antike Dankmäler III/2, 1912/13, 20-27, tavv. 20-21.
Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893
Picozzi 1971: Vittorio Picozzi, "Contributi numismatici all'identificazione del Colosso di Barletta", Rivista Italiana di Numismatica 73, 1971, 107-126. Purpura 1991: Gianfranco Purpura, "Il Colosso di Barletta e il codice di Teodosio II", in Atti del IX Convegno Internazionale dell'Accademia Costantiniana di Perugia (Perugia, 2 - 6 ottobre 1989), Perugia 1993, 457- 480.
Testini 1973: Pasquale Testini, "La statua di bronzo o 'Colosso' di Barletta", Vetera Christianorum, 10, 1973, 127-152. | |
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Stefania Tuccinardi | |
| Data di compilazione | 24/09/2013 18:52:26 | |
| Data ultima revisione | 14/05/2017 11:18:30 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Reperto Archeologico/286 |
| Denominazione | Barletta, Archivio storico del Comune | |
|---|---|---|
| Scheda CittÓ | Barletta | |
| Sede storica | La sede dell'archivio della città sorge accanto alla chiesa del Santo Sepolcro e fu costruita a spese dell'Università. Oggi i documenti sono conservati presso la Biblioteca comunale S. Loffredo. | |
| Tipologia | ||
| Soggetti produttori |
Universitas di Barletta Comune di Barletta | |
| Storia dell'archivio | ||
| Consistenza dell'Archivio | ||
| Fondi archivistici |
Fondi antichi 1. Fondo pergamenaceo 2. Fondo cartaceo | |
| Strumenti di corredo | ||
| Raccolte e miscellanee | ||
| Note | La sede storica dell'archivio è, almeno dal 1567, una stanza sovrapposta alla sagrestia della chiesa del Santo Sepolcro, la cui costruzione fu finanziata dalla stessa Universitas. All'esterno della sagrestia la presenza dell'archivio cittadino era segnalata da due iscrizioni ancora leggibili: una datata 1567, e un'altra al 1784. All'interno, sull'architrave della porta che conduceva all'archivio, e che ora è murata, resta lo stemma cittadino. Prima del 1567, e almeno dal 1491, in conformità agli statuti approvati da re Ferrante d'Aragona, l'archivio dell'Università consisteva in una cassa in cui erano conservati il sigillo, il libro del cancellerato, le bussole e i sacchetti per l'elezione dei priori, altre scritture e libri prodotti dagli ufficiali cittadini. La cassa era custodita nella chiesa del Santo Sepolcro, e chiusa con sei chiavi, ciascuna delle quali affidata ad uno dei sei priori in carica. La cassa custodia del sigillo dovette essere adottata almeno dal 1466, secondo gli statuti di quell'anno, ma verosimilmente non aveva ancora una sede stabile. Gli statuti approvati nel 1521 dal viceré Raimondo de Cardona menzionano un archivio sito nella casa del Capitano e contenente i libri dei percettori e dei cancellieri insieme all'inventario delle scritture dell'Università. Probabilmente nell'Archivio creato nel 1567 confluirono sia la cassa già presente nella chiesa sia il "detto armario" che si trovava nella casa del Capitano. | |
| Bibliografia | ||
| Allegati | ||
| Link esterni | ||
| Schedatore | Veronica Mele | |
| Data di creazione | 13/12/2013 14:18:05 | |
| Data ultima revisione | 06/04/2017 16:37:02 | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Scheda Archivio/10 |
| Nome | Barletta | |
|---|---|---|
| Status amministrativo | Comune capoluogo di provincia (insieme a Trani e Andria) | |
| Estensione del territorio comunale | 149.35 Kmq | |
| Popolazione | 94.814 (ISTAT gennaio 2016) | |
| Musei | Museo civico; Museo della Cattedrale; Pinacoteca De Nittis; Tesoro della basilica del Santo Sepolcro, Antiquarium di Canne | |
| Archivi | Archivio storico del Comune di Barletta (presso Archivio di Stato di Bari, sezione di Barletta); Archivio storico diocesano Pio IX | |
| Biblioteche | Biblioteca comunale Sabino Loffredo; Biblioteca arcivescovile Pio IX | |
| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Citta/20 |

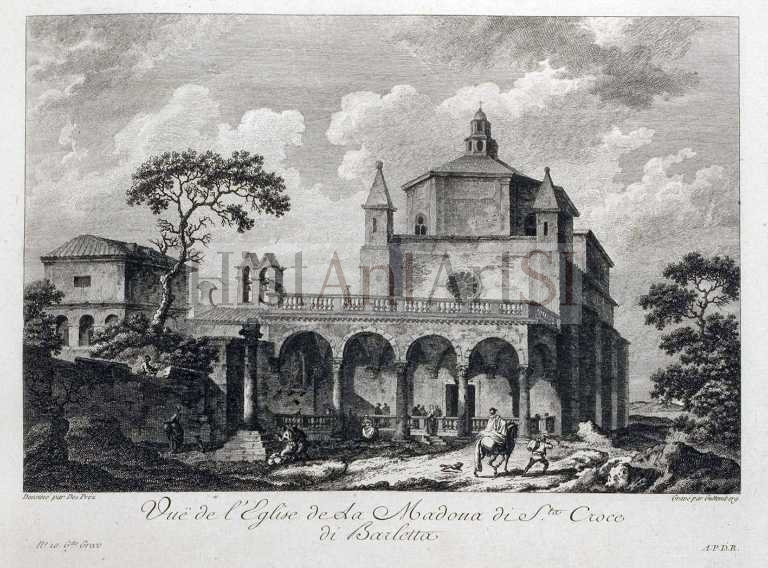















 Apri
Apri



